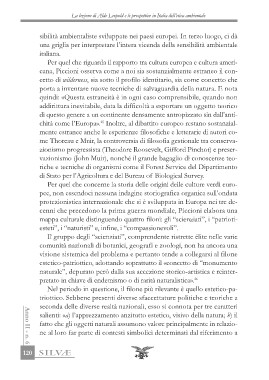Page 117 - SilvaeAnno02n06-005-Sommario-pagg.004.qxp
P. 117
La lezione di Aldo Leopold e le prospettive in Italia dell’etica ambientale
sibilità ambientaliste sviluppate nei paesi europei. In terzo luogo, ci dà
una griglia per interpretare l’intera vicenda della sensibilità ambientale
italiana.
Per quel che riguarda il rapporto tra cultura europea e cultura ameri-
cana, Piccioni osserva come a noi sia sostanzialmente estraneo il con-
cetto di wilderness, sia sotto il profilo identitario, sia come concetto che
porta a inventare nuove tecniche di salvaguardia della natura. E nota
quindi: «Questa estraneità è in ogni caso comprensibile, quando non
addirittura inevitabile, data la difficoltà a esportare un oggetto teorico
di questo genere a un continente densamente antropizzato sin dall’anti-
chità come l’Europa». Inoltre, al dibattito europeo restano sostanzial-
25
mente estranee anche le esperienze filosofiche e letterarie di autori co-
me Thoreau e Muir, la controversia di filosofia gestionale tra conserva-
zionismo progressista (Theodore Roosevelt, Gifford Pinchot) e preser-
vazionismo (John Muir), nonché il grande bagaglio di conoscenze teo-
riche e tecniche di organismi come il Forest Service del Dipartimento
di Stato per l’Agricoltura e del Bureau of Biological Survey.
Per quel che concerne la storia delle origini delle culture verdi euro-
pee, non essendoci nessuna indagine storiografica organica sull’ondata
protezionistica internazionale che si è sviluppata in Europa nei tre de-
cenni che precedono la prima guerra mondiale, Piccioni elabora una
mappa culturale distinguendo quattro filoni: gli “scienziati”, i “patrioti-
esteti”, i “naturisti” e, infine, i “compassionevoli”.
Il gruppo degli “scienziati”, comprendente ristrette élite nelle varie
comunità nazionali di botanici, geografi e zoologi, non ha ancora una
visione sistemica del problema e pertanto tende a collegarsi al filone
estetico-patriottico, adottando soprattutto il «concetto di “monumento
naturale”, depurato però dalla sua accezione storico-artistica e reinter-
pretato in chiave di endemismo o di rarità naturalistica». 26
Nel periodo in questione, il filone più rilevante è quello estetico-pa-
triottico. Sebbene presenti diverse sfaccettature politiche e teoriche a
seconda delle diverse realtà nazionali, esso si connota per tre caratteri
salienti: «a) l’apprezzamento anzitutto estetico, visivo della natura; b) il
fatto che gli oggetti naturali assumono valore principalmente in relazio-
Anno
ne al loro far parte di contesti simbolici determinati dal riferimento a
II
-
n.
6
120 SILVÆ