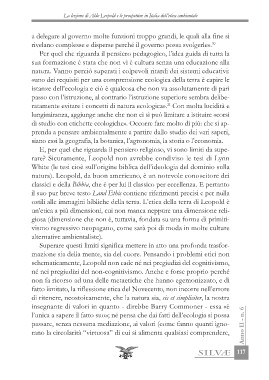Page 114 - SilvaeAnno02n06-005-Sommario-pagg.004.qxp
P. 114
La lezione di Aldo Leopold e le prospettive in Italia dell’etica ambientale
a delegare al governo molte funzioni troppo grandi, le quali alla fine si
rivelano complesse e disperse perché il governo possa svolgerle». 20
Per quel che riguarda il pensiero pedagogico, l’idea guida di tutta la
sua formazione è stata che non vi è cultura senza una educazione alla
natura. Vanno perciò superati i colpevoli ritardi dei sistemi educativi:
«uno dei requisiti per una comprensione ecologica della terra è capire le
istanze dell’ecologia e ciò è qualcosa che non va assolutamente di pari
passo con l’istruzione, al contrario l’istruzione superiore sembra delibe-
ratamente evitare i concetti di natura ecologica». Con molta lucidità e
21
lungimiranza, aggiunge anche che non ci si può limitare a istituire «corsi
di studio con etichette ecologiche». Occorre fare molto di più: che si ap-
prenda a pensare ambientalmente a partire dallo studio dei vari saperi,
siano essi la geografia, la botanica, l’agronomia, la storia o l’economia.
E, per quel che riguarda il pensiero religioso, vi sono limiti da supe-
rare? Sicuramente, Leopold non avrebbe condiviso le tesi di Lynn
White (le tesi cioè sull’origine biblica dell’ideologia del dominio sulla
natura). Leopold, da buon americano, è un notevole conoscitore dei
classici e della Bibbia, che è per lui il classico per eccellenza. E pertanto
il suo pur breve testo Land Ethic contiene riferimenti precisi e per nulla
ostili alle immagini bibliche della terra. L’etica della terra di Leopold è
un’etica a più dimensioni, cui non manca neppure una dimensione reli-
giosa (dimensione che non è, tuttavia, fondata su una forma di primiti-
vismo regressivo neopagano, come sarà poi di moda in molte culture
alternative ambientaliste).
Superare questi limiti significa mettere in atto una profonda trasfor-
mazione sia della mente, sia del cuore. Pensando i problemi etici non
schematicamente, Leopold non cade né nei pregiudizi del cognitivismo,
né nei pregiudizi del non-cognitivismo. Anche e forse proprio perché
non fa ricorso ad una delle metaetiche che hanno egemonizzato, e di
fatto limitato, la riflessione etica del Novecento, non incorre nell’errore
di ritenere, neostoicamente, che la natura sia, sic et simpliciter, la nostra
insegnante di valori in quanto - direbbe Barry Commoner - essa «è 6
l’unica a sapere il fatto suo»; né pensa che dai fatti dell’ecologia si possa n.
passare, senza nessuna mediazione, ai valori (come fanno quanti igno- - II
rano la circolarità “virtuosa” di cui si alimenta qualsiasi comprendere,
Anno
SILVÆ 117