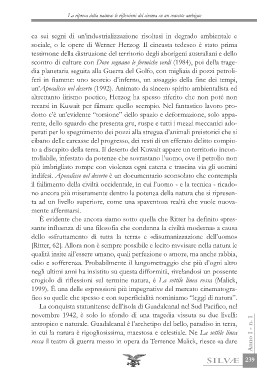Page 235 - 0848_boiardi_interno.qxp
P. 235
La ripresa della natura: le riflessioni del cinema su un concetto ambiguo
ca sui segni di un’industrializzazione risoltasi in degrado ambientale e
sociale, o le opere di Werner Herzog. Il cineasta tedesco è stato prima
testimone della distruzione del territorio degli aborigeni australiani e dello
scontro di culture con Dove sognano le formiche verdi (1984), poi della trage-
dia planetaria seguita alla Guerra del Golfo, con migliaia di pozzi petroli-
feri in fiamme: uno scorcio d’inferno, un assaggio della fine dei tempi,
un’Apocalisse nel deserto (1992). Animato da sincero spirito ambientalista ed
altrettanto lirismo poetico, Herzog ha spesso riferito che non poté non
recarsi in Kuwait per filmare quello scempio. Nel fantastico lavoro pro-
dotto c’è un’evidente “torsione” dello spazio e deformazione, solo appa-
rente, dello sguardo che presenta gru, ruspe e tutti i mezzi meccanici ado-
perati per lo spegnimento dei pozzi alla stregua d’animali preistorici che si
cibano delle carcasse del progresso, dei resti di un efferato delitto compiu-
to a discapito della terra. Il deserto del Kuwait appare un territorio incon-
trollabile, infestato da potenze che sovrastano l’uomo, ove il petrolio non
più imbrigliato rompe con violenza ogni catena e trascina via gli uomini
indifesi. Apocalisse nel deserto è un documentario sconsolato che contempla
il fallimento della civiltà occidentale, in cui l’uomo - e la tecnica - ricado-
no ancora più miseramente dentro la potenza della natura che si ripresen-
ta ad un livello superiore, come una spaventosa realtà che vuole nuova-
mente affermarsi.
È evidente che ancora siamo sotto quella che Ritter ha definito «pres-
sante influenza di una filosofia che condanna la civiltà moderna» a causa
dello «sfruttamento di tutta la terra» e «disumanizzazione dell’uomo»
[Ritter, 62]. Allora non è sempre possibile e lecito ravvisare nella natura le
qualità insite all’essere umano, quali perfezione o amore, ma anche rabbia,
odio e sofferenza. Probabilmente il lungometraggio che più d’ogni altro
negli ultimi anni ha insistito su questa difformità, rivelandosi un possente
crogiolo di riflessioni sul termine natura, è La sottile linea rossa (Malick,
1999). È una delle espressioni più impegnative del mercato cinematogra-
fico su quelle che spesso e con superficialità nominiamo “leggi di natura”.
La conquista statunitense dell’isola di Guadalcanal nel Sud Pacifico, nel
novembre 1942, è solo lo sfondo di una tragedia vissuta su due livelli:
antropico e naturale. Guadalcanal è l’archetipo del bello, paradiso in terra, .1
in cui la natura è rigogliosissima, maestosa e celestiale. Ne La sottile linea oI-n
rossa il teatro di guerra messo in opera da Terrence Malick, riesce «a dare n
n
A
SILVÆ 239