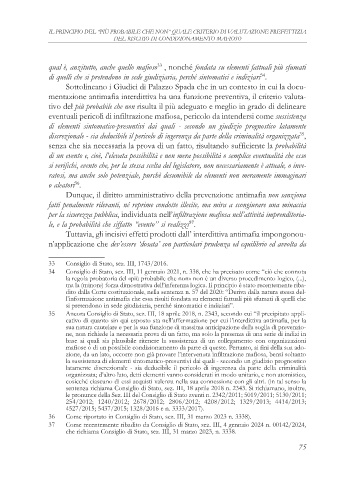Page 77 - Rassegna 2024-4_1
P. 77
IL PRINCIPIO DEL “PIÙ PROBABILE CHE NON” QUALE CRITERIO DI VALUTAZIONE PREFETTIZIA
DEL RISCHIO DI CONDIZIONAMENTO MAFIOSO
33
qual è, anzitutto, anche quello mafioso , nonché fondata su elementi fattuali più sfumati
di quelli che si pretendono in sede giudiziaria, perché sintomatici e indiziari .
34
Sottolineano i Giudici di Palazzo Spada che in un contesto in cui la docu-
mentazione antimafia interdittiva ha una funzione preventiva, il criterio valuta-
tivo del più probabile che non risulta il più adeguato e meglio in grado di delineare
eventuali pericoli di infiltrazione mafiosa, pericolo da intendersi come sussistenza
di elementi sintomatico-presuntivi dai quali - secondo un giudizio prognostico latamente
discrezionale - sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata ,
35
senza che sia necessaria la prova di un fatto, risultando sufficiente la probabilità
di un evento e, cioè, l’elevata possibilità e non mera possibilità o semplice eventualità che esso
si verifichi, evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inve-
ratosi, ma anche solo potenziale, purchè desumibile da elementi non meramente immaginari
o aleatori .
36
Dunque, il diritto amministrativo della prevenzione antimafia non sanziona
fatti penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite, ma mira a scongiurare una minaccia
per la sicurezza pubblica, individuata nell’infiltrazione mafiosa nell’attività imprenditoria-
le, e la probabilità che siffatto “evento” si realizzi .
37
Tuttavia, gli incisivi effetti prodotti dall’ interdittiva antimafia impongonou-
n’applicazione che dev’essere ‘dosata’ con particolari prudenza ed equilibrio ed avvolta da
33 Consiglio di Stato, sez. III, 1743/2016.
34 Consiglio di Stato, sez. III, 11 gennaio 2021, n. 338, che ha precisato come “ciò che connota
la regola probatoria del «più probabile che non» non è un diverso procedimento logico, (...),
ma la (minore) forza dimostrativa dell’inferenza logica. Il principio è stato recentemente riba-
dito dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 57 del 2020: “Deriva dalla natura stessa del-
l’informazione antimafia che essa risulti fondata su elementi fattuali più sfumati di quelli che
si pretendono in sede giudiziaria, perché sintomatici e indiziari”.
35 Ancora Consiglio di Stato, sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343, secondo cui “il precipitato appli-
cativo di quanto sin qui esposto sta nell’affermazione per cui l’interdittiva antimafia, per la
sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzio-
ne, non richiede la necessaria prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in
base ai quali sia plausibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni
mafiose o di un possibile condizionamento da parte di queste. Pertanto, ai fini della sua ado-
zione, da un lato, occorre non già provare l’intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto
la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali - secondo un giudizio prognostico
latamente discrezionale - sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità
organizzata; d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico,
cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri. (in tal senso la
sentenza richiama Consiglio di Stato, sez. III, 18 aprile 2018 n. 2343. Si richiamano, inoltre,
le pronunce della Sez. III del Consiglio di Stato aventi n. 2342/2011; 5019/2011; 5130/2011;
254/2012; 1240/2012; 2678/2012; 2806/2012; 4208/2012; 1329/2013; 4414/2013;
4527/2015; 5437/2015; 1328/2016 e n. 3333/2017).
36 Come riportato in Consiglio di Stato, sez. III, 31 marzo 2023 n. 3338).
37 Come recentemente ribadito da Consiglio di Stato, sez. III, 4 gennaio 2024 n. 00142/2024,
che richiama Consiglio di Stato, sez. III, 31 marzo 2023, n. 3338.
75