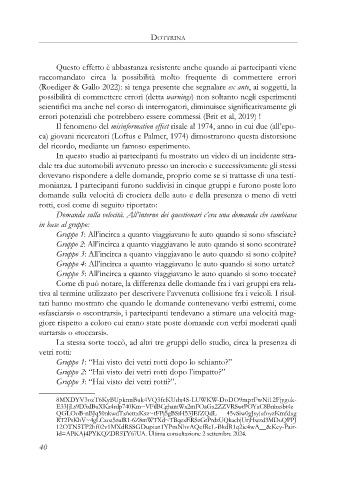Page 42 - Rassegna 2024-4_1
P. 42
DOTTRINA
Questo effetto è abbastanza resistente anche quando ai partecipanti viene
raccomandato circa la possibilità molto frequente di commettere errori
(Roediger & Gallo 2022): si tenga presente che segnalare ex ante, ai soggetti, la
possibilità di commettere errori (detta warnings) non soltanto negli esperimenti
scientifici ma anche nel corso di interrogatori, diminuisce significativamente gli
errori potenziali che potrebbero essere commessi (Brit et al, 2019) !
Il fenomeno del misinformation effect risale al 1974, anno in cui due (all’epo-
ca) giovani ricercatori (Loftus e Palmer, 1974) dimostrarono questa distorsione
del ricordo, mediante un famoso esperimento.
In questo studio ai partecipanti fu mostrato un video di un incidente stra-
dale tra due automobili avvenuto presso un incrocio e successivamente gli stessi
dovevano rispondere a delle domande, proprio come se si trattasse di una testi-
monianza. I partecipanti furono suddivisi in cinque gruppi e furono poste loro
domande sulla velocità di crociera delle auto e della presenza o meno di vetri
rotti, così come di seguito riportato:
Domanda sulla velocità. All’interno dei questionari c’era una domanda che cambiava
in base al gruppo:
Gruppo 1: All’incirca a quanto viaggiavano le auto quando si sono sfasciate?
Gruppo 2: All’incirca a quanto viaggiavano le auto quando si sono scontrate?
Gruppo 3: All’incirca a quanto viaggiavano le auto quando si sono colpite?
Gruppo 4: All’incirca a quanto viaggiavano le auto quando si sono urtate?
Gruppo 5: All’incirca a quanto viaggiavano le auto quando si sono toccate?
Come di può notare, la differenza delle domande fra i vari gruppi era rela-
tiva al termine utilizzato per descrivere l’avvenuta collisione fra i veicoli. I risul-
tati hanno mostrato che quando le domande contenevano verbi estremi, come
«sfasciarsi» o «scontrarsi», i partecipanti tendevano a stimare una velocità mag-
giore rispetto a coloro cui erano state poste domande con verbi moderati quali
«urtarsi» o «toccarsi».
La stessa sorte toccò, ad altri tre gruppi dello studio, circa la presenza di
vetri rotti:
Gruppo 1: “Hai visto dei vetri rotti dopo lo schianto?”
Gruppo 2: “Hai visto dei vetri rotti dopo l’impatto?”
Gruppo 3: “Hai visto dei vetri rotti?”.
8MXDYV3ozT6KyBUpknnBuk4VQ3fcKUdx4S-LUWKW-DoDO9mprFwNi12Fjyguk-
E33JjLs9D3xlBuXKz4rdp740Km~VFtlBCghamWx2mFOaGx2ZZVRSwtPOYxC8Bnbxsbt4z
QGLOoB-nBJq50nkwdTx6ettxKsz~tFPj5gBSiH53JEfZQdL 45vSiw0gJsyiufoyzKmfdxg
RT2PsKhV~4gLCxoa5zulR1-6Z8mWTXd~TBqexERSzGtPrdzUQkacbjUrjHwzd3MDuQPPJ
12OTN5TP2hf02v1MXdRSSGDupian1YPmNhvAQcfReL-BkdR1q2ie4wA__&Key-Pair-
Id=APKAJ4PYKQZDR5TY67UA. Ultima consultazione 2 settembre 2024.
40