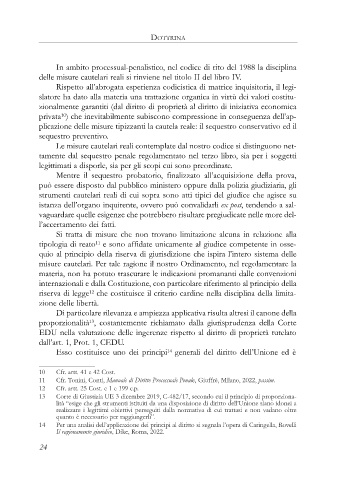Page 26 - Rassegna 2024-3
P. 26
DOTTRINA
In ambito processual-penalistico, nel codice di rito del 1988 la disciplina
delle misure cautelari reali si rinviene nel titolo II del libro IV.
Rispetto all’abrogata esperienza codicistica di matrice inquisitoria, il legi-
slatore ha dato alla materia una trattazione organica in virtù dei valori costitu-
zionalmente garantiti (dal diritto di proprietà al diritto di iniziativa economica
privata ) che inevitabilmente subiscono compressione in conseguenza dell’ap-
10
plicazione delle misure tipizzanti la cautela reale: il sequestro conservativo ed il
sequestro preventivo.
Le misure cautelari reali contemplate dal nostro codice si distinguono net-
tamente dal sequestro penale regolamentato nel terzo libro, sia per i soggetti
legittimati a disporle, sia per gli scopi cui sono preordinate.
Mentre il sequestro probatorio, finalizzato all’acquisizione della prova,
può essere disposto dal pubblico ministero oppure dalla polizia giudiziaria, gli
strumenti cautelari reali di cui sopra sono atti tipici del giudice che agisce su
istanza dell’organo inquirente, ovvero può convalidarli ex post, tendendo a sal-
vaguardare quelle esigenze che potrebbero risultare pregiudicate nelle more del-
l’accertamento dei fatti.
Si tratta di misure che non trovano limitazione alcuna in relazione alla
tipologia di reato e sono affidate unicamente al giudice competente in osse-
11
quio al principio della riserva di giurisdizione che ispira l’intero sistema delle
misure cautelari. Per tale ragione il nostro Ordinamento, nel regolamentare la
materia, non ha potuto trascurare le indicazioni promananti dalle convenzioni
internazionali e dalla Costituzione, con particolare riferimento al principio della
riserva di legge che costituisce il criterio cardine nella disciplina della limita-
12
zione delle libertà.
Di particolare rilevanza e ampiezza applicativa risulta altresì il canone della
proporzionalità , costantemente richiamato dalla giurisprudenza della Corte
13
EDU nella valutazione delle ingerenze rispetto al diritto di proprietà tutelato
dall’art. 1, Prot. 1, CEDU.
Esso costituisce uno dei principi generali del diritto dell’Unione ed è
14
10 Cfr. artt. 41 e 42 Cost.
11 Cfr. Tonini, Conti, Manuale di Diritto Processuale Penale, Giuffrè, Milano, 2022, passim.
12 Cfr. artt. 25 Cost. e 1 e 199 c.p.
13 Corte di Giustizia UE 3 dicembre 2019, C-482/17, secondo cui il principio di proporziona-
lità “esige che gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell’Unione siano idonei a
realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non vadano oltre
quanto è necessario per raggiungerli”.
14 Per una analisi dell’applicazione dei principi al diritto si segnala l’opera di Caringella, Rovelli
Il ragionamento giuridico, Dike, Roma, 2022.
24