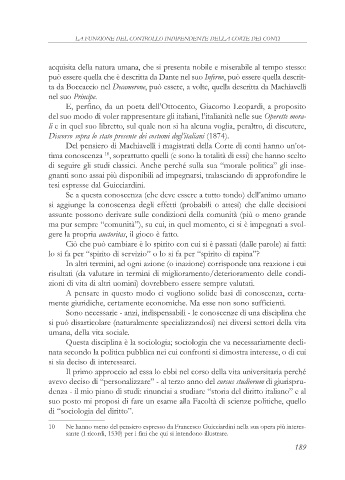Page 191 - Rassegna 2024-3
P. 191
LA FUNZIONE DEL CONTROLLO INDIPENDENTE DELLA CORTE DEI CONTI
acquisita della natura umana, che si presenta nobile e miserabile al tempo stesso:
può essere quella che è descritta da Dante nel suo Inferno, può essere quella descrit-
ta da Boccaccio nel Decamerone, può essere, a volte, quella descritta da Machiavelli
nel suo Principe.
E, perfino, da un poeta dell’Ottocento, Giacomo Leopardi, a proposito
del suo modo di voler rappresentare gli italiani, l’italianità nelle sue Operette mora-
li e in quel suo libretto, sul quale non si ha alcuna voglia, peraltro, di discutere,
Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’italiani (1874).
Del pensiero di Machiavelli i magistrati della Corte di conti hanno un’ot-
tima conoscenza , soprattutto quelli (e sono la totalità di essi) che hanno scelto
10
di seguire gli studi classici. Anche perché sulla sua “morale politica” gli inse-
gnanti sono assai più disponibili ad impegnarsi, tralasciando di approfondire le
tesi espresse dal Guicciardini.
Se a questa conoscenza (che deve essere a tutto tondo) dell’animo umano
si aggiunge la conoscenza degli effetti (probabili o attesi) che dalle decisioni
assunte possono derivare sulle condizioni della comunità (più o meno grande
ma pur sempre “comunità”), su cui, in quel momento, ci si è impegnati a svol-
gere la propria auctoritas, il gioco è fatto.
Ciò che può cambiare è lo spirito con cui si è passati (dalle parole) ai fatti:
lo si fa per “spirito di servizio” o lo si fa per “spirito di rapina”?
In altri termini, ad ogni azione (o inazione) corrisponde una reazione i cui
risultati (da valutare in termini di miglioramento/deterioramento delle condi-
zioni di vita di altri uomini) dovrebbero essere sempre valutati.
A pensare in questo modo ci vogliono solide basi di conoscenza, certa-
mente giuridiche, certamente economiche. Ma esse non sono sufficienti.
Sono necessarie - anzi, indispensabili - le conoscenze di una disciplina che
si può disarticolare (naturalmente specializzandosi) nei diversi settori della vita
umana, della vita sociale.
Questa disciplina è la sociologia; sociologia che va necessariamente decli-
nata secondo la politica pubblica nei cui confronti si dimostra interesse, o di cui
si sia deciso di interessarci.
Il primo approccio ad essa lo ebbi nel corso della vita universitaria perché
avevo deciso di “personalizzare” - al terzo anno del cursus studiorum di giurispru-
denza - il mio piano di studi: rinunciai a studiare “storia del diritto italiano” e al
suo posto mi proposi di fare un esame alla Facoltà di scienze politiche, quello
di “sociologia del diritto”.
10 Ne hanno meno del pensiero espresso da Francesco Guicciardini nella sua opera più interes-
sante (I ricordi, 1530) per i fini che qui si intendono illustrare.
189