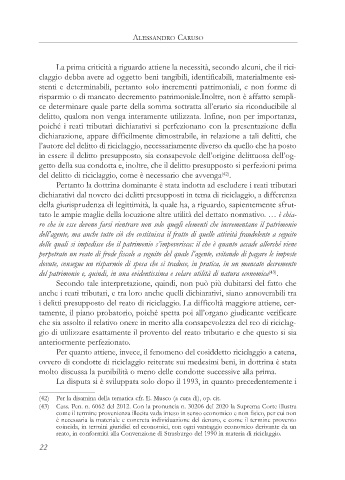Page 24 - Rassegna 2023-4_Inserto
P. 24
ALESSANDRO CARUSO
La prima criticità a riguardo attiene la necessità, secondo alcuni, che il rici-
claggio debba avere ad oggetto beni tangibili, identificabili, materialmente esi-
stenti e determinabili, pertanto solo incrementi patrimoniali, e non forme di
risparmio o di mancato decremento patrimoniale.Inoltre, non è affatto sempli-
ce determinare quale parte della somma sottratta all’erario sia riconducibile al
delitto, qualora non venga interamente utilizzata. Infine, non per importanza,
poiché i reati tributari dichiarativi si perfezionano con la presentazione della
dichiarazione, appare difficilmente dimostrabile, in relazione a tali delitti, che
l’autore del delitto di riciclaggio, necessariamente diverso da quello che ha posto
in essere il delitto presupposto, sia consapevole dell’origine delittuosa dell’og-
getto della sua condotta e, inoltre, che il delitto presupposto si perfezioni prima
del delitto di riciclaggio, come è necessario che avvenga .
(42)
Pertanto la dottrina dominante è stata indotta ad escludere i reati tributari
dichiarativi dal novero dei delitti presupposti in tema di riciclaggio, a differenza
della giurisprudenza di legittimità, la quale ha, a riguardo, sapientemente sfrut-
tato le ampie maglie della locuzione altre utilità del dettato normativo. … è chia-
ro che in esse devono farsi rientrare non solo quegli elementi che incrementano il patrimonio
dell’agente, ma anche tutto ciò che costituisca il frutto di quelle attività fraudolente a seguito
delle quali si impedisce che il patrimonio s’impoverisca: il che è quanto accade allorché viene
perpetrato un reato di frode fiscale a seguito del quale l’agente, evitando di pagare le imposte
dovute, consegue un risparmio di spesa che si traduce, in pratica, in un mancato decremento
del patrimonio e, quindi, in una evidentissima e solare utilità di natura economica .
(43)
Secondo tale interpretazione, quindi, non può più dubitarsi del fatto che
anche i reati tributari, e tra loro anche quelli dichiarativi, siano annoverabili tra
i delitti presupposto del reato di riciclaggio. La difficoltà maggiore attiene, cer-
tamente, il piano probatorio, poiché spetta poi all’organo giudicante verificare
che sia assolto il relativo onere in merito alla consapevolezza del reo di riciclag-
gio di utilizzare esattamente il provento del reato tributario e che questo si sia
anteriormente perfezionato.
Per quanto attiene, invece, il fenomeno del cosiddetto riciclaggio a catena,
ovvero di condotte di riciclaggio reiterate sui medesimi beni, in dottrina è stata
molto discussa la punibilità o meno delle condotte successive alla prima.
La disputa si è sviluppata solo dopo il 1993, in quanto precedentemente i
(42) Per la disamina della tematica cfr. E. Musco (a cura di), op. cit.
(43) Cass. Pen. n. 6062 del 2012. Con la pronuncia n. 30206 del 2020 la Suprema Corte illustra
come il termine provenienza illecita vada inteso in senso economico e non fisico, per cui non
è necessaria la materiale e concreta individuazione del denaro, e come il termine provento
coincida, in termini giuridici ed economici, con ogni vantaggio economico derivante da un
reato, in conformità alla Convenzione di Strasburgo del 1990 in materia di riciclaggio.
22