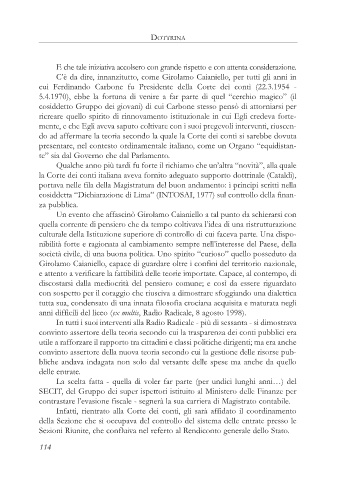Page 116 - Rassegna 2023-2
P. 116
DOTTRINA
E che tale iniziativa accolsero con grande rispetto e con attenta considerazione.
C’è da dire, innanzitutto, come Girolamo Caianiello, per tutti gli anni in
cui Ferdinando Carbone fu Presidente della Corte dei conti (22.3.1954 -
5.4.1970), ebbe la fortuna di venire a far parte di quel “cerchio magico” (il
cosiddetto Gruppo dei giovani) di cui Carbone stesso pensò di attorniarsi per
ricreare quello spirito di rinnovamento istituzionale in cui Egli credeva forte-
mente, e che Egli aveva saputo coltivare con i suoi pregevoli interventi, riuscen-
do ad affermare la teoria secondo la quale la Corte dei conti si sarebbe dovuta
presentare, nel contesto ordinamentale italiano, come un Organo “equidistan-
te” sia dal Governo che dal Parlamento.
Qualche anno più tardi fu forte il richiamo che un’altra “novità”, alla quale
la Corte dei conti italiana aveva fornito adeguato supporto dottrinale (Cataldi),
portava nelle fila della Magistratura del buon andamento: i principi scritti nella
cosiddetta “Dichiarazione di Lima” (INTOSAI, 1977) sul controllo della finan-
za pubblica.
Un evento che affascinò Girolamo Caianiello a tal punto da schierarsi con
quella corrente di pensiero che da tempo coltivava l’idea di una ristrutturazione
culturale della Istituzione superiore di controllo di cui faceva parte. Una dispo-
nibilità forte e ragionata al cambiamento sempre nell’interesse del Paese, della
società civile, di una buona politica. Uno spirito “curioso” quello posseduto da
Girolamo Caianiello, capace di guardare oltre i confini del territorio nazionale,
e attento a verificare la fattibilità delle teorie importate. Capace, al contempo, di
discostarsi dalla mediocrità del pensiero comune; e così da essere riguardato
con sospetto per il coraggio che riusciva a dimostrare sfoggiando una dialettica
tutta sua, condensato di una innata filosofia crociana acquisita e maturata negli
anni difficili del liceo (ex multis, Radio Radicale, 8 agosto 1998).
In tutti i suoi interventi alla Radio Radicale - più di sessanta - si dimostrava
convinto assertore della teoria secondo cui la trasparenza dei conti pubblici era
utile a rafforzare il rapporto tra cittadini e classi politiche dirigenti; ma era anche
convinto assertore della nuova teoria secondo cui la gestione delle risorse pub-
bliche andava indagata non solo dal versante delle spese ma anche da quello
delle entrate.
La scelta fatta - quella di voler far parte (per undici lunghi anni…) del
SECIT, del Gruppo dei super ispettori istituito al Ministero delle Finanze per
contrastare l’evasione fiscale - segnerà la sua carriera di Magistrato contabile.
Infatti, rientrato alla Corte dei conti, gli sarà affidato il coordinamento
della Sezione che si occupava del controllo del sistema delle entrate presso le
Sezioni Riunite, che confluiva nel referto al Rendiconto generale dello Stato.
114