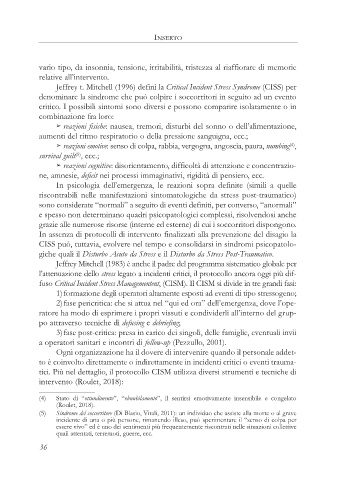Page 38 - Rassegna 2023-2_inserto
P. 38
INSERTO
vario tipo, da insonnia, tensione, irritabilità, tristezza al riaffiorare di memorie
relative all’intervento.
Jeffrey t. Mitchell (1996) definì la Critical Incident Stress Syndrome (CISS) per
denominare la sindrome che può colpire i soccorritori in seguito ad un evento
critico. I possibili sintomi sono diversi e possono comparire isolatamente o in
combinazione fra loro:
reazioni fisiche: nausea, tremori, disturbi del sonno o dell’alimentazione,
aumenti del ritmo respiratorio o della pressione sanguigna, ecc.;
reazioni emotive: senso di colpa, rabbia, vergogna, angoscia, paura, numbing ,
(4)
survival guilt , ecc.;
(5)
reazioni cognitive: disorientamento, difficoltà di attenzione e concentrazio-
ne, amnesie, deficit nei processi immaginativi, rigidità di pensiero, ecc.
In psicologia dell’emergenza, le reazioni sopra definite (simili a quelle
riscontrabili nelle manifestazioni sintomatologiche da stress post-traumatico)
sono considerate “normali” a seguito di eventi definiti, per converso, “anormali”
e spesso non determinano quadri psicopatologici complessi, risolvendosi anche
grazie alle numerose risorse (interne ed esterne) di cui i soccorritori dispongono.
In assenza di protocolli di intervento finalizzati alla prevenzione del disagio la
CISS può, tuttavia, evolvere nel tempo e consolidarsi in sindromi psicopatolo-
giche quali il Disturbo Acuto da Stress e il Disturbo da Stress Post-Traumatico.
Jeffrey Mitchell (1983) è anche il padre del programma sistematico globale per
l’attenuazione dello stress legato a incidenti critici, il protocollo ancora oggi più dif-
fuso Critical Incident Stress Managementent, (CISM). Il CISM si divide in tre grandi fasi:
1)formazione degli operatori altamente esposti ad eventi di tipo stressogeno;
2)fase pericritica: che si attua nel “qui ed ora” dell’emergenza, dove l’ope-
ratore ha modo di esprimere i propri vissuti e condividerli all’interno del grup-
po attraverso tecniche di defusing e debriefing;
3)fase post-critica: presa in carico dei singoli, delle famiglie, eventuali invii
a operatori sanitari e incontri di follow-up (Pezzullo, 2001).
Ogni organizzazione ha il dovere di intervenire quando il personale addet-
to è coinvolto direttamente o indirettamente in incidenti critici o eventi trauma-
tici. Più nel dettaglio, il protocollo CISM utilizza diversi strumenti e tecniche di
intervento (Roulet, 2018):
(4) Stato di “ottundimento”, “obnubilamento”, il sentirsi emotivamente insensibile e congelato
(Roulet, 2018).
(5) Sindrome del soccorritore (Di Blasio, Vitali, 2011): un individuo che assiste alla morte o al grave
incidente di una o più persone, rimanendo illeso, può sperimentare il “senso di colpa per
essere vivo” ed è uno dei sentimenti più frequentemente riscontrati nelle situazioni collettive
quali attentati, terremoti, guerre, ecc.
36