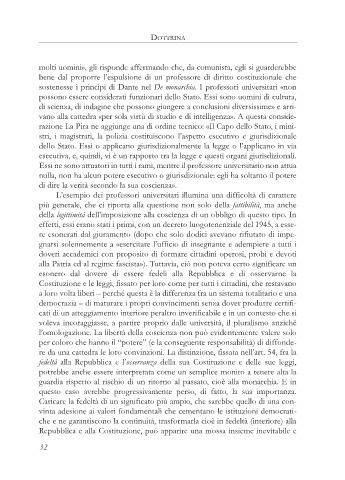Page 34 - Rassegna 2023-1
P. 34
DOTTRINA
molti uomini», gli risponde affermando che, da comunista, egli si guarderebbe
bene dal proporre l’espulsione di un professore di diritto costituzionale che
sostenesse i principi di Dante nel De monarchia. I professori universitari «non
possono essere considerati funzionari dello Stato. Essi sono uomini di cultura,
di scienza, di indagine che possono giungere a conclusioni diversissime» e arri-
vano alla cattedra «per sola virtù di studio e di intelligenza». A questa conside-
razione La Pira ne aggiunge una di ordine tecnico: «Il Capo dello Stato, i mini-
stri, i magistrati, la polizia costituiscono l’aspetto esecutivo e giurisdizionale
dello Stato. Essi o applicano giurisdizionalmente la legge o l’applicano in via
esecutiva, e, quindi, vi è un rapporto tra la legge e questi organi giurisdizionali.
Essi ne sono attuatori in tutti i rami, mentre il professore universitario non attua
nulla, non ha alcun potere esecutivo o giurisdizionale: egli ha soltanto il potere
di dire la verità secondo la sua coscienza».
L’esempio dei professori universitari illumina una difficoltà di carattere
più generale, che ci riporta alla questione non solo della fattibilità, ma anche
della legittimità dell’imposizione alla coscienza di un obbligo di questo tipo. In
effetti, essi erano stati i primi, con un decreto luogotenenziale del 1945, a esse-
re esonerati dal giuramento (dopo che solo dodici avevano rifiutato di impe-
gnarsi solennemente a «esercitare l’ufficio di insegnante e adempiere a tutti i
doveri accademici con proposito di formare cittadini operosi, probi e devoti
alla Patria ed al regime fascista»). Tuttavia, ciò non poteva certo significare un
esonero dal dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la
Costituzione e le leggi, fissato per loro come per tutti i cittadini, che restavano
a loro volta liberi – perché questa è la differenza fra un sistema totalitario e una
democrazia – di maturare i propri convincimenti senza dover produrre certifi-
cati di un atteggiamento interiore peraltro inverificabile e in un contesto che si
voleva incoraggiasse, a partire proprio dalle università, il pluralismo anziché
l’omologazione. La libertà della coscienza non può evidentemente valere solo
per coloro che hanno il “potere” (e la conseguente responsabilità) di diffonde-
re da una cattedra le loro convinzioni. La distinzione, fissata nell’art. 54, fra la
fedeltà alla Repubblica e l’osservanza della sua Costituzione e delle sue leggi,
potrebbe anche essere interpretata come un semplice monito a tenere alta la
guardia rispetto al rischio di un ritorno al passato, cioè alla monarchia. E in
questo caso avrebbe progressivamente perso, di fatto, la sua importanza.
Caricare la fedeltà di un significato più ampio, che sarebbe quello di una con-
vinta adesione ai valori fondamentali che cementano le istituzioni democrati-
che e ne garantiscono la continuità, trasformarla cioè in fedeltà (interiore) alla
Repubblica e alla Costituzione, può apparire una mossa insieme inevitabile e
32