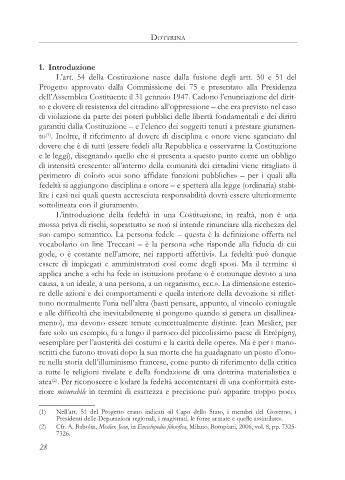Page 30 - Rassegna 2023-1
P. 30
DOTTRINA
1. Introduzione
L’art. 54 della Costituzione nasce dalla fusione degli artt. 50 e 51 del
Progetto approvato dalla Commissione dei 75 e presentato alla Presidenza
dell’Assemblea Costituente il 31 gennaio 1947. Cadono l’enunciazione del dirit-
to e dovere di resistenza del cittadino all’oppressione – che era previsto nel caso
di violazione da parte dei poteri pubblici delle libertà fondamentali e dei diritti
garantiti dalla Costituzione – e l’elenco dei soggetti tenuti a prestare giuramen-
to . Inoltre, il riferimento al dovere di disciplina e onore viene sganciato dal
(1)
dovere che è di tutti (essere fedeli alla Repubblica e osservarne la Costituzione
e le leggi), disegnando quello che si presenta a questo punto come un obbligo
di intensità crescente: all’interno della comunità dei cittadini viene ritagliato il
perimetro di coloro «cui sono affidate funzioni pubbliche» – per i quali alla
fedeltà si aggiungono disciplina e onore – e spetterà alla legge (ordinaria) stabi-
lire i casi nei quali questa accresciuta responsabilità dovrà essere ulteriormente
sottolineata con il giuramento.
L’introduzione della fedeltà in una Costituzione, in realtà, non è una
mossa priva di rischi, soprattutto se non si intende rinunciare alla ricchezza del
suo campo semantico. La persona fedele – questa è la definizione offerta nel
vocabolario on line Treccani – è la persona «che risponde alla fiducia di cui
gode, o è costante nell’amore, nei rapporti affettivi». La fedeltà può dunque
essere di impiegati e amministratori così come degli sposi. Ma il termine si
applica anche a «chi ha fede in istituzioni profane o è comunque devoto a una
causa, a un ideale, a una persona, a un organismo, ecc.». La dimensione esterio-
re delle azioni e dei comportamenti e quella interiore della devozione si riflet-
tono normalmente l’una nell’altra (basti pensare, appunto, al vincolo coniugale
e alle difficoltà che inevitabilmente si pongono quando si genera un disallinea-
mento), ma devono essere tenute concettualmente distinte. Jean Meslier, per
fare solo un esempio, fu a lungo il parroco del piccolissimo paese di Etrépigny,
«esemplare per l’austerità dei costumi e la carità delle opere». Ma è per i mano-
scritti che furono trovati dopo la sua morte che ha guadagnato un posto d’ono-
re nella storia dell’illuminismo francese, come punto di riferimento della critica
a tutte le religioni rivelate e della fondazione di una dottrina materialistica e
atea . Per riconoscere e lodare la fedeltà accontentarsi di una conformità este-
(2)
riore misurabile in termini di esattezza e precisione può apparire troppo poco.
(1) Nell’art. 51 del Progetto erano indicati «il Capo dello Stato, i membri del Governo, i
Presidenti delle Deputazioni regionali, i magistrati, le forze armate e quelle assimilate».
(2) Cfr. A. Babolin, Meslier, Jean, in Enciclopedia filosofica, Milano, Bompiani, 2006, vol. 8, pp. 7325-
7326.
28