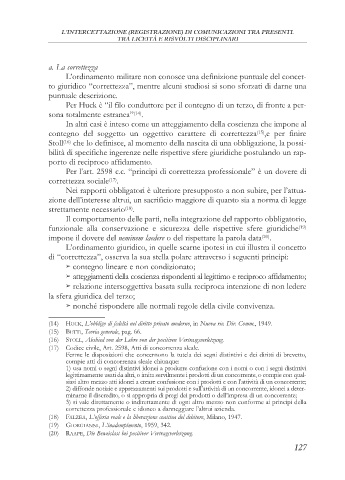Page 129 - Rassegna 2022-3
P. 129
L’INTERCETTAZIONE (REGISTRAZIONE) DI COMUNICAZIONI TRA PRESENTI.
TRA LICEITÀ E RISVOLTI DISCIPLINARI
a. La correttezza
L’ordinamento militare non conosce una definizione puntuale del concet-
to giuridico “correttezza”, mentre alcuni studiosi si sono sforzati di darne una
puntuale descrizione.
Per Huck è “il filo conduttore per il contegno di un terzo, di fronte a per-
sona totalmente estranea” .
(14)
In altri casi è inteso come un atteggiamento della coscienza che impone al
contegno del soggetto un oggettivo carattere di correttezza ,e per finire
(15)
Stoll che lo definisce, al momento della nascita di una obbligazione, la possi-
(16)
bilità di specifiche ingerenze nelle rispettive sfere giuridiche postulando un rap-
porto di reciproco affidamento.
Per l’art. 2598 c.c. “principi di correttezza professionale” è un dovere di
correttezza sociale .
(17)
Nei rapporti obbligatori è ulteriore presupposto a non subire, per l’attua-
zione dell’interesse altrui, un sacrificio maggiore di quanto sia a norma di legge
strettamente necessario .
(18)
Il comportamento delle parti, nella integrazione del rapporto obbligatorio,
funzionale alla conservazione e sicurezza delle rispettive sfere giuridiche
(19)
impone il dovere del neminem laedere o del rispettare la parola data .
(20)
L’ordinamento giuridico, in quelle scarne ipotesi in cui illustra il concetto
di “correttezza”, osserva la sua stella polare attraverso i seguenti principi:
contegno lineare e non condizionato;
atteggiamenti della coscienza rispondenti al legittimo e reciproco affidamento;
relazione intersoggettiva basata sulla reciproca intenzione di non ledere
la sfera giuridica del terzo;
nonché rispondere alle normali regole della civile convivenza.
(14) HUCK, L’obbligo di fedeltà nel diritto privato moderno, in Nuova riv. Dir. Comm., 1949.
(15) BETTI, Teoria generale, pag. 66.
(16) STOLL, Abshied von der Lehre von der positiven Vertrasgsverletzung.
(17) Codice civile, Art. 2598, Atti di concorrenza sleale.
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto,
compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi
legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qual-
siasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a deter-
minarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della
correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.
(18) FALZEA, L’offerta reale e la liberazione coattiva del debitore, Milano, 1947.
(19) GIORGIANNI, L’inadempimento, 1959, 342.
(20) RAAPE, Die Beweislast bei positiver Vertragsverletzung.
127