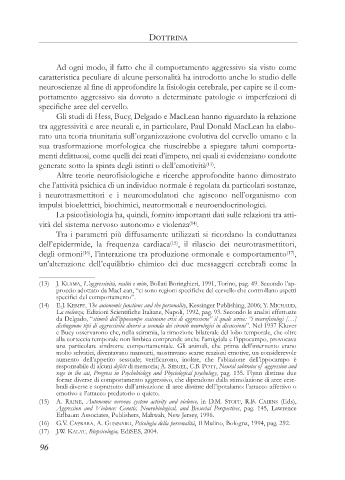Page 98 - Rassegna 2022-1_2
P. 98
DOTTRINA
Ad ogni modo, il fatto che il comportamento aggressivo sia visto come
caratteristica peculiare di alcune personalità ha introdotto anche lo studio delle
neuroscienze al fine di approfondire la fisiologia cerebrale, per capire se il com-
portamento aggressivo sia dovuto a determinate patologie o imperfezioni di
specifiche aree del cervello.
Gli studi di Hess, Bucy, Delgado e MacLean hanno riguardato la relazione
tra aggressività e aree neurali e, in particolare, Paul Donald MacLean ha elabo-
rato una teoria triunitaria sull’organizzazione evolutiva del cervello umano e la
sua trasformazione morfologica che riuscirebbe a spiegare taluni comporta-
menti delittuosi, come quelli dei reati d’impeto, nei quali si evidenziano condotte
generate sotto la spinta degli istinti o dell’emotività .
(13)
Altre teorie neurofisiologiche e ricerche approfondite hanno dimostrato
che l’attività psichica di un individuo normale è regolata da particolari sostanze,
i neurotrasmettitori e i neuromodulatori che agiscono nell’organismo con
impulsi bioelettrici, biochimici, neurormonali e neuroendocrinologici.
La psicofisiologia ha, quindi, fornito importanti dati sulle relazioni tra atti-
vità del sistema nervoso autonomo e violenza .
(14)
Tra i parametri più diffusamente utilizzati si ricordano la conduttanza
dell’epidermide, la frequenza cardiaca , il rilascio dei neurotrasmettitori,
(15)
degli ormoni , l’interazione tra produzione ormonale e comportamento ,
(17)
(16)
un’alterazione dell’equilibrio chimico dei due messaggeri cerebrali come la
(13) J. KLAMA, L’aggressività, realtà e mito, Bollati Boringhieri, 1991, Torino, pag. 49. Secondo l’ap-
proccio adottato da MacLean, “ci sono regioni specifiche del cervello che controllano aspetti
specifici del comportamento”.
(14) E.J. KEMPF, The autonomic functions and the personality, Kessinger Publishing, 2006; Y. MICHAUD,
La violenza, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1992, pag. 93. Secondo le analisi effettuate
da Delgado, “stimoli dell’ippocampo scatenano crisi di aggressione” il quale scrive: “i neurofisiologi […]
distinguono tipi di aggressività diversi a seconda dei circuiti neurologici in discussione”. Nel 1937 Kluver
e Bucy osservarono che, nella scimmia, la rimozione bilaterale del lobo temporale, che oltre
alla corteccia temporale non limbica comprende anche l’amigdala e l’ippocampo, provocava
una particolare sindrome comportamentale. Gli animali, che prima dell’intervento erano
molto selvatici, diventavano mansueti, mostravano scarse reazioni emotive, un considerevole
aumento dell’appetito sessuale; verificarono, inoltre, che l’ablazione dell’ippocampo è
responsabile di alcuni deficit di memoria; A. SIEGEL, C.B. POTT, Neural subtrates of aggression and
rage in the cat, Progress in Psychobiology and Physiological psychology, pag. 135. Flynn distinse due
forme diverse di comportamento aggressivo, che dipendono dalla stimolazione di aree cere-
brali diverse e soprattutto dall’attivazione di aree distinte dell’ipotalamo: l’attacco affettivo o
emotivo e l’attacco predatorio o quieto.
(15) A. RAINE, Autonomic nervous system activity and violence, in D.M. STOFF, R.B. CAIRNS (Eds),
Aggression and Violence: Genetic, Neurobiological, and Biosocial Perspectives, pag. 145, Lawrence
Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey, 1996.
(16) G.V. CAPRARA, A. GENNARO, Psicologia della personalità, Il Mulino, Bologna, 1994, pag. 292.
(17) J.W. KALAT, Biopsicologia, EdiSES, 2004.
96