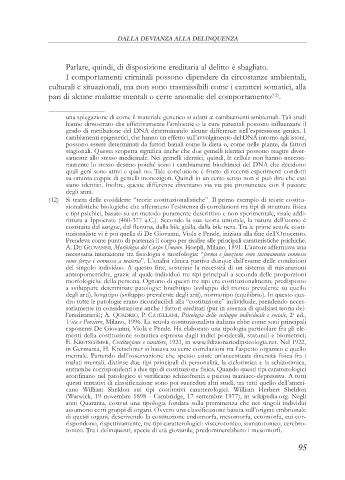Page 97 - Rassegna 2022-1_2
P. 97
DALLA DEVIANZA ALLA DELINQUENZA
Parlare, quindi, di disposizione ereditaria al delitto è sbagliato.
I comportamenti criminali possono dipendere da circostanze ambientali,
culturali e situazionali, ma non sono trasmissibili come i caratteri somatici, alla
pari di alcune malattie mentali o certe anomalie del comportamento .
(12)
una spiegazione di come il materiale genetico si adatti ai cambiamenti ambientali. Tali studi
hanno dimostrato che effettivamente l’ambiente o le cure parentali possono influenzare il
grado di metilazione del DNA determinando alcune differenze nell’espressione genica. I
cambiamenti epigenetici, che hanno un effetto sull’avvolgimento del DNA intorno agli istoni,
possono essere determinati da fattori banali come la dieta o, come nelle piante, da fattori
stagionali. Questa scoperta significa anche che due gemelli identici possono reagire diver-
samente allo stesso medicinale. Nei gemelli identici, quindi, le cellule non hanno necessa-
riamente lo stesso destino poiché sono i cambiamenti biochimici del DNA che decidono
quali geni sono attivi e quali no. Tale conclusione è frutto di recenti esperimenti condotti
su ottanta coppie di gemelli monozigoti. Quindi in un certo senso non si può dire che essi
siano identici. Inoltre, queste differenze diventano via via più pronunciate con il passare
degli anni.
(12) Si tratta delle cosiddette “teorie costituzionalistiche”. Il primo esempio di teorie costitu-
zionalistiche biologiche che affermano l’esistenza di correlazioni tra tipi di struttura fisica
e tipi psichici, basato su un metodo puramente descrittivo e non sperimentale, risale addi-
rittura a Ippocrate (460-377 a.C.). Secondo la sua teoria umorale, la natura dell’uomo è
costituita dal sangue, dal flemma, dalla bile gialla, dalla bile nera. Tra le prime scuole costi-
tuzionaliste vi è poi quella di De Giovanni, Viola e Pende, iniziata alla fine dell’Ottocento.
Prendeva come punto di partenza il corpo per risalire alle principali caratteristiche psichiche.
A. DE GIOVANNI, Morfologia del Corpo Umano. Hoepli, Milano, 1891. L’autore affermava una
necessaria interazione tra fisiologia e morfologia: “forma e funzione sono intimamente connesse
come forza è connessa a materia”. L’analisi clinica partiva dunque dall’esame delle condizioni
del singolo individuo. A questo fine, sostenne la necessità di un sistema di misurazioni
antropometriche, grazie al quale individuò tre tipi principali a seconda delle proporzioni
morfologiche della persona. Ognuno di questi tre tipi era costituzionalmente predisposto
a sviluppare determinate patologie: brachitipo (sviluppo del tronco prevalente su quello
degli arti), longitipo (sviluppo prevalente degli arti), normotipo (equilibrio). In questo qua-
dro tutte le patologie erano riconducibili alla “costituzione” individuale, prendendo neces-
sariamente in considerazione anche i fattori ereditari (pur in assenza di qualsiasi teoria del-
a
l’ereditarietà); A. QUADRIO, P. CATELLANI, Psicologia dello sviluppo individuale e sociale, 2 ed.,
Vita e Pensiero, Milano, 1996. La scuola costituzionalista italiana ebbe come suoi principali
esponenti De Giovanni, Viola e Pende. Ha elaborato una tipologia particolare fra gli ele-
menti della costituzione somatica espressa dagli indici ponderali, staturali e biometrici;
E. KRETSCHMER, Costituzione e carattere, 1921, in www.ildizionariodipsicologia.net. Nel 1922,
in Germania, H. Kretschmer si basava su certe correlazioni tra l’aspetto organico e quello
mentale. Partendo dall’osservazione che spesso esiste un’accentuata diversità fisica fra i
malati mentali, distinse due tipi principali di personalità, la ciclotimica e la schizotimica,
entrambe corrispondenti a due tipi di costituzione fisica. Quando questi tipi caratterologici
sconfinano nel patologico si verificano schizofrenia e psicosi maniaco-depressiva. A tutti
questi tentativi di classificazione sono poi succeduti altri studi, tra tutti quello dell’ameri-
cano William Sheldon sui tipi costitutivi caratterologici. William Herbert Sheldon
(Warwick, 19 novembre 1898 - Cambridge, 17 settembre 1977), in wikipedia.org. Negli
anni Quaranta, costruì una tipologia fondata sulla preminenza che nei singoli individui
assumono certi gruppi di organi. Ovvero una classificazione basata sull’origine embrionale
di questi organi, descrivendo la costituzione endomorfa, mesomorfa, ectomorfa, cui cor-
rispondono, rispettivamente, tre tipi caratterologici: viscerotonico, somatotonico, cerebro-
tonico. Tra i delinquenti, specie di età giovanile, predominerebbero i mesomorfi.
95