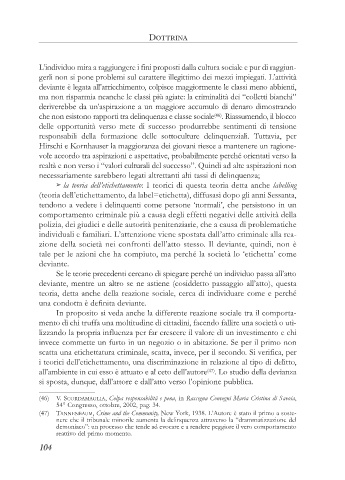Page 106 - Rassegna 2022-1_2
P. 106
DOTTRINA
L’individuo mira a raggiungere i fini proposti dalla cultura sociale e pur di raggiun-
gerli non si pone problemi sul carattere illegittimo dei mezzi impiegati. L’attività
deviante è legata all’arricchimento, colpisce maggiormente le classi meno abbienti,
ma non risparmia neanche le classi più agiate: la criminalità dei “colletti bianchi”
deriverebbe da un’aspirazione a un maggiore accumulo di denaro dimostrando
che non esistono rapporti tra delinquenza e classe sociale . Riassumendo, il blocco
(46)
delle opportunità verso mete di successo produrrebbe sentimenti di tensione
responsabili della formazione delle sottoculture delinquenziali. Tuttavia, per
Hirschi e Kornhauser la maggioranza dei giovani riesce a mantenere un ragione-
vole accordo tra aspirazioni e aspettative, probabilmente perché orientati verso la
realtà e non verso i “valori culturali del successo”. Quindi ad alte aspirazioni non
necessariamente sarebbero legati altrettanti alti tassi di delinquenza;
la teoria dell’etichettamento: I teorici di questa teoria detta anche labelling
(teoria dell’etichettamento, da label=etichetta), diffusasi dopo gli anni Sessanta,
tendono a vedere i delinquenti come persone ‘normali’, che persistono in un
comportamento criminale più a causa degli effetti negativi delle attività della
polizia, dei giudici e delle autorità penitenziarie, che a causa di problematiche
individuali e familiari. L’attenzione viene spostata dall’atto criminale alla rea-
zione della società nei confronti dell’atto stesso. Il deviante, quindi, non è
tale per le azioni che ha compiuto, ma perché la società lo ‘etichetta’ come
deviante.
Se le teorie precedenti cercano di spiegare perché un individuo passa all’atto
deviante, mentre un altro se ne astiene (cosiddetto passaggio all’atto), questa
teoria, detta anche della reazione sociale, cerca di individuare come e perché
una condotta è definita deviante.
In proposito si veda anche la differente reazione sociale tra il comporta-
mento di chi truffa una moltitudine di cittadini, facendo fallire una società o uti-
lizzando la propria influenza per far crescere il valore di un investimento e chi
invece commette un furto in un negozio o in abitazione. Se per il primo non
scatta una etichettatura criminale, scatta, invece, per il secondo. Si verifica, per
i teorici dell’etichettamento, una discriminazione in relazione al tipo di delitto,
all’ambiente in cui esso è attuato e al ceto dell’autore . Lo studio della devianza
(47)
si sposta, dunque, dall’attore e dall’atto verso l’opinione pubblica.
(46) V. SCORDAMAGLIA, Colpa responsabilità e pena, in Rassegna Convegni Maria Cristina di Savoia,
54° Congresso, ottobre, 2002, pag. 34.
(47) TANNENBAUM, Crime and the Community, New York, 1938. L’Autore è stato il primo a soste-
nere che il tribunale minorile aumenta la delinquenza attraverso la “drammatizzazione del
demoniaco”: un processo che tende ad evocare e a rendere peggiore il vero comportamento
reattivo del primo momento.
104