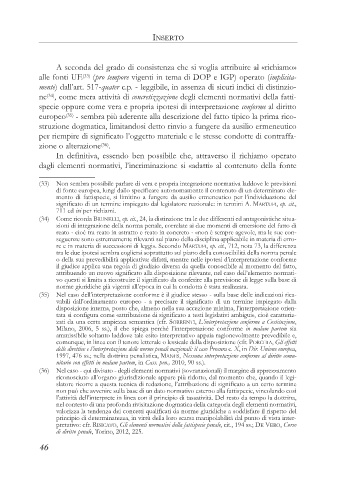Page 48 - Rassegna 2022-1_inserto
P. 48
INSERTO
A seconda del grado di consistenza che si voglia attribuire al «richiamo»
alle fonti UE (pro tempore vigenti in tema di DOP e IGP) operato (implicita-
(33)
mente) dall’art. 517-quater c.p. - leggibile, in assenza di sicuri indici di distinzio-
ne , come mera attività di concretizzazione degli elementi normativi della fatti-
(34)
specie oppure come vera e propria ipotesi di interpretazione conforme al diritto
europeo - sembra più aderente alla descrizione del fatto tipico la prima rico-
(35)
struzione dogmatica, limitandosi detto rinvio a fungere da ausilio ermeneutico
per riempire di significato l’oggetto materiale e le stesse condotte di contraffa-
zione o alterazione .
(36)
In definitiva, essendo ben possibile che, attraverso il richiamo operato
dagli elementi normativi, l’incriminazione si «adatti» al contenuto della fonte
(33) Non sembra possibile parlare di vera e propria integrazione normativa laddove le previsioni
di fonte europea, lungi dallo specificare autonomamente il contenuto di un determinato ele-
mento di fattispecie, si limitino a fungere da ausilio ermeneutico per l’individuazione del
significato di un termine impiegato dal legislatore nazionale: in termini A. MARTUFI, op. cit.,
711 ed ivi per richiami.
(34) Come ricorda BRUNELLI, op. cit., 24, la distinzione tra le due differenti ed antagonistiche situa-
zioni di integrazione della norma penale, correlate ai due momenti di emersione del fatto di
reato - cioè tra reato in astratto e reato in concreto - «non è sempre agevole, ma le sue con-
seguenze sono estremamente rilevanti sul piano della disciplina applicabile in materia di erro-
re e in materia di successioni di leggi». Secondo MARTUFI, op. cit., 712, nota 73, la differenza
tra le due ipotesi sembra cogliersi soprattutto sul piano della conoscibilità della norma penale
o della sua prevedibilità applicativa: difatti, mentre nelle ipotesi d’interpretazione conforme
il giudice applica una regola di giudizio diversa da quella conoscibile al momento del fatto,
attribuendo un nuovo significato alla disposizione rilevante, nel caso dell’elemento normati-
vo questi si limita a ricostruire il significato da conferire alla previsione di legge sulla base di
norme giuridiche già vigenti all’epoca in cui la condotta è stata realizzata.
(35) Nel caso dell’interpretazione conforme è il giudice stesso - sulla base delle indicazioni rica-
vabili dall’ordinamento europeo - a precisare il significato di un termine impiegato dalla
disposizione interna, posto che, almeno nella sua accezione minima, l’interpretazione orien-
tata si configura come «attribuzione di significato a testi legislativi ambigui», cioè caratteriz-
zati da una certa ampiezza semantica (cfr. SORRENTI, L’interpretazione conforme a Costituzione,
Milano, 2006, 5 ss.), il che spiega perché l’interpretazione conforme in malam partem sia
ammissibile soltanto laddove tale esito interpretativo appaia ragionevolmente prevedibile e,
comunque, in linea con il tenore letterale o lessicale della disposizione (cfr. PORCHIA, Gli effetti
delle direttive e l’interpretazione delle norme penali nazionali: il caso Procura c. X, in Dir. Unione europea,
1997, 476 ss.; nella dottrina penalistica, MANES, Nessuna interpretazione conforme al diritto comu-
nitario con effetti in malam partem, in Cass. pen., 2010, 90 ss.).
(36) Nel caso - qui divisato - degli elementi normativi (sovranazionali) il margine di apprezzamento
riconosciuto all’organo giurisdizionale appare più ridotto, dal momento che, quando il legi-
slatore ricorre a questa tecnica di redazione, l’attribuzione di significato a un certo termine
non può che avvenire sulla base di un dato normativo esterno alla fattispecie, vincolando così
l’attività dell’interprete in linea con il principio di tassatività. Del resto da tempo la dottrina,
nel contesto di una profonda rivisitazione dogmatica della categoria degli elementi normativi,
valorizza la tendenza dei concetti qualificati da norme giuridiche a soddisfare il rispetto del
principio di determinatezza, in virtù della loro scarsa manipolabilità dal punto di vista inter-
pretativo: cfr. RISICATO, Gli elementi normativi della fattispecie penale, cit., 194 ss.; DE VERO, Corso
di diritto penale, Torino, 2012, 225.
46