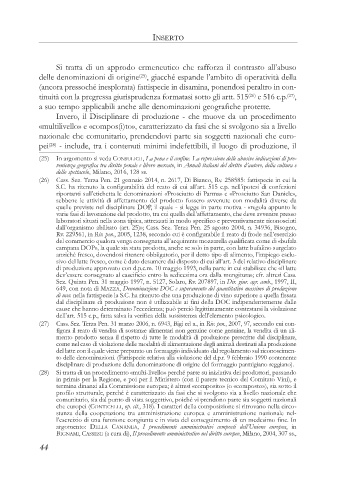Page 46 - Rassegna 2022-1_inserto
P. 46
INSERTO
Si tratta di un approdo ermeneutico che rafforza il contrasto all’abuso
delle denominazioni di origine , giacché espande l’ambito di operatività della
(25)
(ancora pressoché inesplorata) fattispecie in disamina, ponendosi peraltro in con-
tinuità con la pregressa giurisprudenza formatasi sotto gli artt. 515 e 516 c.p. ,
(26)
(27)
a suo tempo applicabili anche alle denominazioni geografiche protette.
Invero, il Disciplinare di produzione - che muove da un procedimento
«multilivello» e «compos(i)to», caratterizzato da fasi che si svolgono sia a livello
nazionale che comunitario, prendendovi parte sia soggetti nazionali che euro-
pei - include, tra i contenuti minimi indefettibili, il luogo di produzione, il
(28)
(25) In argomento si veda CONSULICH, La pena e il confine. La repressione delle abusive indicazioni di pro-
venienza geografica tra diritto penale e libero mercato, in Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e
dello spettacolo, Milano, 2016, 128 ss.
(26) Cass. Sez. Terza Pen. 21 gennaio 2014, n. 2617, Di Bianco, Rv. 258585: fattispecie in cui la
S.C. ha ritenuto la configurabilità del reato di cui all’art. 515 c.p. nell’ipotesi di confezioni
riportanti sull’etichetta le denominazioni «Prosciutto di Parma» e «Prosciutto San Daniele»,
sebbene le attività di affettamento del prodotto fossero avvenute con modalità diverse da
quelle previste nel disciplinare DOP, il quale - si legge in parte motiva - «regola appunto le
varie fasi di lavorazione del prodotto, tra cui quella dell’affettamento, che deve avvenire presso
laboratori situati nella zona tipica, attrezzati in modo specifico e preventivamente riconosciuti
dall’organismo abilitato (art. 25)»; Cass. Sez. Terza Pen. 25 agosto 2004, n. 34936, Bisogno,
Rv. 229561, in Riv. pen., 2005, 1238, secondo cui è configurabile il reato di frode nell’esercizio
del commercio qualora venga consegnata all’acquirente mozzarella qualificata come di «bufala
campana DOP», la quale sia stata prodotta, anche se solo in parte, con latte bufalino surgelato
anziché fresco, dovendosi ritenere obbligatorio, per il detto tipo di alimento, l’impiego esclu-
sivo del latte fresco, come è dato desumere dal disposto di cui all’art. 3 del relativo disciplinare
di produzione approvato con d.p.c.m. 10 maggio 1993, nella parte in cui stabilisce che «il latte
dev’essere consegnato al caseificio entro la sedicesima ora dalla mungitura»; cfr. altresì Cass.
Sez. Quinta Pen. 31 maggio 1997, n. 5127, Solaro, Rv. 207897, in Dir. giur. agr. amb., 1997, II,
649, con nota di MAZZA, Denominazione DOC e superamento del quantitativo massimo di produzione
di uva: nella fattispecie la S.C. ha ritenuto che una produzione di vino superiore a quella fissata
dal disciplinare di produzione non è utilizzabile ai fini della DOC indipendentemente dalle
cause che hanno determinato l’eccedenza; può perciò legittimamente contestarsi la violazione
dell’art. 515 c.p., fatta salva la verifica della sussistenza dell’elemento psicologico.
(27) Cass. Sez. Terza Pen. 31 marzo 2006, n. 6943, Bigi ed a., in Riv. pen., 2007, 97, secondo cui con-
figura il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, la vendita di un ali-
mento prodotto senza il rispetto di tutte le modalità di produzione prescritte dal disciplinare,
come nel caso di violazione delle modalità di alimentazione degli animali destinati alla produzione
del latte con il quale viene preparato un formaggio individuato dal regolamento sul riconoscimen-
to delle denominazioni. (Fattispecie relativa alla violazione del d.p.r. 9 febbraio 1990 contenente
disciplinare di produzione della denominazione di origine del formaggio parmigiano reggiano).
(28) Si tratta di un procedimento «multi-livello» perché parte su iniziativa dei produttori, passando
in primis per la Regione, e poi per il Ministero (con il parere tecnico del Comitato Vini), e
termina dinanzi alla Commissione europea; è altresì «composito» (o «composto»), sia sotto il
profilo strutturale, perché è caratterizzato da fasi che si svolgono sia a livello nazionale che
comunitario, sia dal punto di vista soggettivo, poiché vi prendono parte sia soggetti nazionali
che europei (CONTICELLI, op. cit., 318). I caratteri della composizione si ritrovano nella circo-
stanza della cooperazione tra amministrazione europea e amministrazione nazionale nel-
l’esercizio di una funzione congiunta e in vista del conseguimento di un medesimo fine. In
argomento: DELLA CANANEA, I procedimenti amministrativi composti dell’Unione europea, in
BIGNAMI, CASSESE (a cura di), Il procedimento amministrativo nel diritto europeo, Milano, 2004, 307 ss.,
44