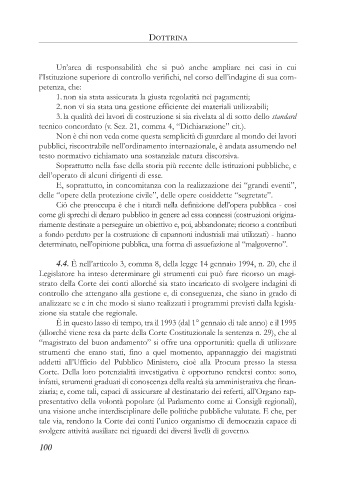Page 102 - Rassegna 2021-4
P. 102
DOTTRINA
Un’area di responsabilità che si può anche ampliare nei casi in cui
l’Istituzione superiore di controllo verifichi, nel corso dell’indagine di sua com-
petenza, che:
1. non sia stata assicurata la giusta regolarità nei pagamenti;
2. non vi sia stata una gestione efficiente dei materiali utilizzabili;
3. la qualità dei lavori di costruzione si sia rivelata al di sotto dello standard
tecnico concordato (v. Sez. 21, comma 4, “Dichiarazione” cit.).
Non è chi non veda come questa semplicità di guardare al mondo dei lavori
pubblici, riscontrabile nell’ordinamento internazionale, è andata assumendo nel
testo normativo richiamato una sostanziale natura discorsiva.
Soprattutto nella fase della storia più recente delle istituzioni pubbliche, e
dell’operato di alcuni dirigenti di esse.
E, soprattutto, in concomitanza con la realizzazione dei “grandi eventi”,
delle “opere della protezione civile”, delle opere cosiddette “segretate”.
Ciò che preoccupa è che i ritardi nella definizione dell’opera pubblica - così
come gli sprechi di denaro pubblico in genere ad essa connessi (costruzioni origina-
riamente destinate a perseguire un obiettivo e, poi, abbandonate; ricorso a contributi
a fondo perduto per la costruzione di capannoni industriali mai utilizzati) - hanno
determinato, nell’opinione pubblica, una forma di assuefazione al “malgoverno”.
4.4. È nell’articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che il
Legislatore ha inteso determinare gli strumenti cui può fare ricorso un magi-
strato della Corte dei conti allorché sia stato incaricato di svolgere indagini di
controllo che attengano alla gestione e, di conseguenza, che siano in grado di
analizzare se e in che modo si siano realizzati i programmi previsti dalla legisla-
zione sia statale che regionale.
È in questo lasso di tempo, tra il 1993 (dal 1° gennaio di tale anno) e il 1995
(allorché viene resa da parte della Corte Costituzionale la sentenza n. 29), che al
“magistrato del buon andamento” si offre una opportunità: quella di utilizzare
strumenti che erano stati, fino a quel momento, appannaggio dei magistrati
addetti all’Ufficio del Pubblico Ministero, cioè alla Procura presso la stessa
Corte. Della loro potenzialità investigativa è opportuno rendersi conto: sono,
infatti, strumenti graduati di conoscenza della realtà sia amministrativa che finan-
ziaria; e, come tali, capaci di assicurare al destinatario dei referti, all’Organo rap-
presentativo della volontà popolare (al Parlamento come ai Consigli regionali),
una visione anche interdisciplinare delle politiche pubbliche valutate. E che, per
tale via, rendono la Corte dei conti l’unico organismo di democrazia capace di
svolgere attività ausiliare nei riguardi dei diversi livelli di governo.
100