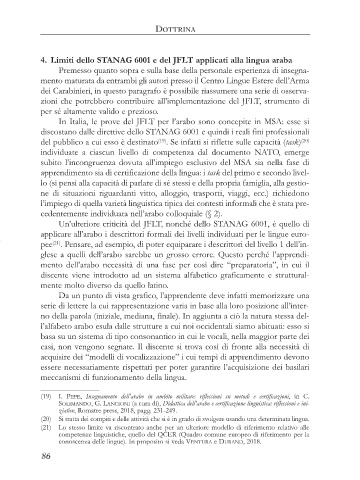Page 88 - Rassegna 2021-2
P. 88
06 Campanelli-Lancioni.qxp_Layout 2 24/09/21 08:34 Pagina 86
DOTTRINA
4. Limiti dello STANAG 6001 e del JFLT applicati alla lingua araba
Premesso quanto sopra e sulla base della personale esperienza di insegna-
mento maturata da entrambi gli autori presso il Centro Lingue Estere dell’Arma
dei Carabinieri, in questo paragrafo è possibile riassumere una serie di osserva-
zioni che potrebbero contribuire all’implementazione del JFLT, strumento di
per sé altamente valido e prezioso.
In Italia, le prove del JFLT per l’arabo sono concepite in MSA: esse si
discostano dalle direttive dello STANAG 6001 e quindi i reali fini professionali
del pubblico a cui esso è destinato . Se infatti si riflette sulle capacità (task)
(20)
(19)
individuate a ciascun livello di competenza dal documento NATO, emerge
subito l’incongruenza dovuta all’impiego esclusivo del MSA sia nella fase di
apprendimento sia di certificazione della lingua: i task del primo e secondo livel-
lo (si pensi alla capacità di parlare di sé stessi e della propria famiglia, alla gestio-
ne di situazioni riguardanti vitto, alloggio, trasporti, viaggi, ecc.) richiedono
l’impiego di quella varietà linguistica tipica dei contesti informali che è stata pre-
cedentemente individuata nell’arabo colloquiale (§ 2).
Un’ulteriore criticità del JFLT, nonché dello STANAG 6001, è quello di
applicare all’arabo i descrittori formali dei livelli individuati per le lingue euro-
pee . Pensare, ad esempio, di poter equiparare i descrittori del livello 1 dell’in-
(21)
glese a quelli dell’arabo sarebbe un grosso errore. Questo perché l’apprendi-
mento dell’arabo necessità di una fase per così dire “preparatoria”, in cui il
discente viene introdotto ad un sistema alfabetico graficamente e struttural-
mente molto diverso da quello latino.
Da un punto di vista grafico, l’apprendente deve infatti memorizzare una
serie di lettere la cui rappresentazione varia in base alla loro posizione all’inter-
no della parola (iniziale, mediana, finale). In aggiunta a ciò la natura stessa del-
l’alfabeto arabo esula dalle strutture a cui noi occidentali siamo abituati: esso si
basa su un sistema di tipo consonantico in cui le vocali, nella maggior parte dei
casi, non vengono segnate. Il discente si trova così di fronte alla necessità di
acquisire dei “modelli di vocalizzazione” i cui tempi di apprendimento devono
essere necessariamente rispettati per poter garantire l’acquisizione dei basilari
meccanismi di funzionamento della lingua.
(19) I. PEPE, Insegnamento dell’arabo in ambito militare: riflessioni su metodi e certificazioni, in C.
SOLIMANDO, G. LANCIONI (a cura di), Didattica dell’arabo e certificazione linguistica: riflessioni e ini-
ziative, Romatre press, 2018, pagg. 231-249.
(20) Si tratta dei compiti e delle attività che si è in grado di svolgere usando una determinata lingua.
(21) Lo stesso limite va riscontrato anche per un ulteriore modello di riferimento relativo alle
competenze linguistiche, quello del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue). In proposito si veda VENTURA e DURAND, 2018.
86