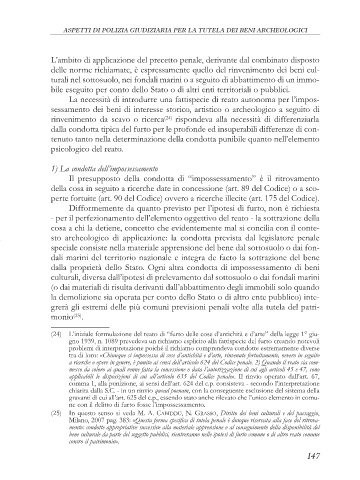Page 149 - Rassegna 2021-2
P. 149
11 Mele (PRIMA PARTE).qxp_Layout 2 24/09/21 08:36 Pagina 147
ASPETTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA PER LA TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI
L’ambito di applicazione del precetto penale, derivante dal combinato disposto
delle norme richiamate, è espressamente quello del rinvenimento dei beni cul-
turali nel sottosuolo, nei fondali marini o a seguito di abbattimento di un immo-
bile eseguito per conto dello Stato o di altri enti territoriali o pubblici.
La necessità di introdurre una fattispecie di reato autonoma per l’impos-
sessamento dei beni di interesse storico, artistico o archeologico a seguito di
rinvenimento da scavo o ricerca rispondeva alla necessità di differenziarla
(24)
dalla condotta tipica del furto per le profonde ed insuperabili differenze di con-
tenuto tanto nella determinazione della condotta punibile quanto nell’elemento
psicologico del reato.
1) La condotta dell’impossessamento
Il presupposto della condotta di “impossessamento” è il ritrovamento
della cosa in seguito a ricerche date in concessione (art. 89 del Codice) o a sco-
perte fortuite (art. 90 del Codice) ovvero a ricerche illecite (art. 175 del Codice).
Difformemente da quanto previsto per l’ipotesi di furto, non è richiesta
- per il perfezionamento dell’elemento oggettivo del reato - la sottrazione della
cosa a chi la detiene, concetto che evidentemente mal si concilia con il conte-
sto archeologico di applicazione: la condotta prevista dal legislatore penale
speciale consiste nella materiale apprensione del bene dal sottosuolo o dai fon-
dali marini del territorio nazionale e integra de facto la sottrazione del bene
dalla proprietà dello Stato. Ogni altra condotta di impossessamento di beni
culturali, diversa dall’ipotesi di prelevamento dal sottosuolo o dai fondali marini
(o dai materiali di risulta derivanti dall’abbattimento degli immobili solo quando
la demolizione sia operata per conto dello Stato o di altro ente pubblico) inte-
grerà gli estremi delle più comuni previsioni penali volte alla tutela del patri-
monio .
(25)
(24) L’iniziale formulazione del reato di “furto delle cose d’antichità e d’arte” della legge 1° giu-
gno 1939, n. 1089 prevedeva un richiamo esplicito alla fattispecie del furto creando notevoli
problemi di interpretazione poiché il richiamo comprendeva condotte estremamente diverse
tra di loro: «Chiunque si impossessa di cose d’antichità e d’arte, rinvenute fortuitamente, ovvero in seguito
a ricerche o opere in genere, è punito ai sensi dell’articolo 624 del Codice penale. 2) Quando il reato sia com-
messo da coloro ai quali venne fatta la concessione o data l’autorizzazione di cui agli articoli 45 e 47, sono
applicabili le disposizioni di cui all’articolo 635 del Codice penale». Il rinvio operato dall’art. 67,
comma 1, alla punizione, ai sensi dell’art. 624 del c.p. consisteva - secondo l’interpretazione
chiarita dalla S.C. - in un rinvio quoad poenam, con la conseguente esclusione del sistema della
gravanti di cui all’art. 625 del c.p., essendo stato anche rilevato che l’unico elemento in comu-
ne con il delitto di furto fosse l’impossessamento.
(25) In questo senso si veda M. A. CABIDDU, N. GRASSO, Diritto dei beni culturali e del paesaggio,
Milano, 2007 pag. 383: «Questa forma specifica di tutela penale è dunque riservata alla fase del ritrova-
mento: condotte appropriative successive alla materiale apprensione o al conseguimento della disponibilità del
bene culturale da parte del soggetto pubblici, rientreranno nelle ipotesi di furto comune o di altro reato comune
contro il patrimonio».
147