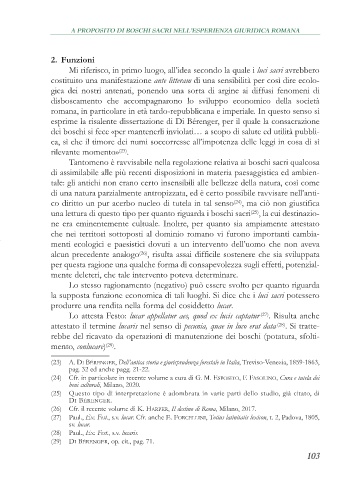Page 105 - Rassegna 2021-2
P. 105
09 Banfi.qxp_Layout 2 24/09/21 08:35 Pagina 103
A PROPOSITO DI BOSCHI SACRI NELL’ESPERIENZA GIURIDICA ROMANA
2. Funzioni
Mi riferisco, in primo luogo, all’idea secondo la quale i luci sacri avrebbero
costituito una manifestazione ante litteram di una sensibilità per così dire ecolo-
gica dei nostri antenati, ponendo una sorta di argine ai diffusi fenomeni di
disboscamento che accompagnarono lo sviluppo economico della società
romana, in particolare in età tardo-repubblicana e imperiale. In questo senso si
esprime la risalente dissertazione di Di Bérenger, per il quale la consacrazione
dei boschi si fece «per mantenerli inviolati… a scopo di salute ed utilità pubbli-
ca, sì che il timore dei numi soccorresse all’impotenza delle leggi in cosa di sì
rilevante momento» .
(23)
Tantomeno è ravvisabile nella regolazione relativa ai boschi sacri qualcosa
di assimilabile alle più recenti disposizioni in materia paesaggistica ed ambien-
tale: gli antichi non erano certo insensibili alle bellezze della natura, così come
di una natura parzialmente antropizzata, ed è certo possibile ravvisare nell’anti-
co diritto un pur acerbo nucleo di tutela in tal senso , ma ciò non giustifica
(24)
una lettura di questo tipo per quanto riguarda i boschi sacri , la cui destinazio-
(25)
ne era eminentemente cultuale. Inoltre, per quanto sia ampiamente attestato
che nei territori sottoposti al dominio romano vi furono importanti cambia-
menti ecologici e paesistici dovuti a un intervento dell’uomo che non aveva
alcun precedente analogo , risulta assai difficile sostenere che sia sviluppata
(26)
per questa ragione una qualche forma di consapevolezza sugli effetti, potenzial-
mente deleteri, che tale intervento poteva determinare.
Lo stesso ragionamento (negativo) può essere svolto per quanto riguarda
la supposta funzione economica di tali luoghi. Si dice che i luci sacri potessero
produrre una rendita nella forma del cosiddetto lucar.
Lo attesta Festo: lucar appellatur aes, quod ex lucis captatur . Risulta anche
(27)
attestato il termine lucaris nel senso di pecunia, quae in luco erat data . Si tratte-
(28)
rebbe del ricavato da operazioni di manutenzione dei boschi (potatura, sfolti-
mento, conlucare) .
(29)
(23) A. DI BÉRENGER, Dell’antica storia e giurisprudenza forestale in Italia, Treviso-Venezia, 1859-1863,
pag. 32 ed anche pagg. 21-22.
(24) Cfr. in particolare in recente volume a cura di G. M. ESPOSITO, F. FASOLINO, Cura e tutela dei
beni culturali, Milano, 2020.
(25) Questo tipo di interpretazione è adombrata in varie parti dello studio, già citato, di
DI BÉRENGER.
(26) Cfr. il recente volume di K. HARPER, Il destino di Roma, Milano, 2017.
(27) Paul., Ex. Fest., s.v. lucar. Cfr. anche E. FORCELLINI, Totius latinitatis lexicon, t. 2, Padova, 1805,
sv. lucar.
(28) Paul., Ex. Fest., s.v. lucaris.
(29) DI BÉRENGER, op. cit., pag. 71.
103