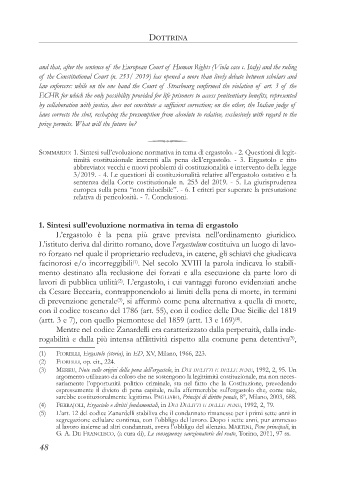Page 52 - Rassegna 2020-3
P. 52
DOTTRINA
and that, after the sentence of the European Court of Human Rights (Viola case c. Italy) and the ruling
of the Constitutional Court (n. 253/ 2019) has opened a more than lively debate between scholars and
law enforcers: while on the one hand the Court of Strasbourg confirmed the violation of art. 3 of the
ECHR for which the only possibility provided for life prisoners to access penitentiary benefits, represented
by collaboration with justice, does not constitute a sufficient correction; on the other, the Italian judge of
laws corrects the shot, reshaping the presumption from absolute to relative, exclusively with regard to the
prize permits. What will the future be?
!
SOMMARIO: 1. Sintesi sull’evoluzione normativa in tema di ergastolo. - 2. Questioni di legit-
timità costituzionale inerenti alla pena dell’ergastolo. - 3. Ergastolo e rito
abbreviato: vecchi e nuovi problemi di costituzionalità e intervento della legge
3/2019. - 4. Le questioni di costituzionalità relative all’ergastolo ostativo e la
sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019. - 5. La giurisprudenza
europea sulla pena “non riducibile”. - 6. I criteri per superare la presunzione
relativa di pericolosità. - 7. Conclusioni.
1. Sintesi sull’evoluzione normativa in tema di ergastolo
L’ergastolo è la pena più grave prevista nell’ordinamento giuridico.
L’istituto deriva dal diritto romano, dove l’ergastulum costituiva un luogo di lavo-
ro forzato nel quale il proprietario recludeva, in catene, gli schiavi che giudicava
facinorosi e/o incorreggibili . Nel secolo XVIII la parola indicava lo stabili-
(1)
mento destinato alla reclusione dei forzati e alla esecuzione da parte loro di
lavori di pubblica utilità . L’ergastolo, i cui vantaggi furono evidenziati anche
(2)
da Cesare Beccaria, contrapponendolo ai limiti della pena di morte, in termini
di prevenzione generale , si affermò come pena alternativa a quella di morte,
(3)
con il codice toscano del 1786 (art. 55), con il codice delle Due Sicilie del 1819
(artt. 3 e 7), con quello piemontese del 1859 (artt. 13 e 169) .
(4)
Mentre nel codice Zanardelli era caratterizzato dalla perpetuità, dalla inde-
rogabilità e dalla più intensa afflittività rispetto alla comune pena detentiva ,
(5)
(1) FIORELLI, Ergastolo (storia), in ED, XV, Milano, 1966, 223.
(2) FIORELLI, op. cit., 224.
(3) MEREU, Note sulle origini della pena dell’ergastolo, in DEI DELITTI E DELLE PENE, 1992, 2, 95. Un
argomento utilizzato da coloro che ne sostengono la legittimità costituzionale, ma non neces-
sariamente l’opportunità politico criminale, sta nel fatto che la Costituzione, prevedendo
espressamente il divieto di pena capitale, nulla affermerebbe sull’ergastolo che, come tale,
sarebbe costituzionalmente legittimo. PAGLIARO, Principi di diritto penale, 8°, Milano, 2003, 688.
(4) FERRAJOLI, Ergastolo e diritti fondamentali, in DEI DELITTI E DELLE PENE, 1992, 2, 79.
(5) L’art. 12 del codice Zanardelli stabiliva che il condannato rimanesse per i primi sette anni in
segregazione cellulare continua, con l’obbligo del lavoro. Dopo i sette anni, pur ammesso
al lavoro insieme ad altri condannati, aveva l’obbligo del silenzio. MARTINI, Pene principali, in
G. A. DE FRANCESCO, (a cura di), Le conseguenze sanzionatorie del reato, Torino, 2011, 97 ss.
48