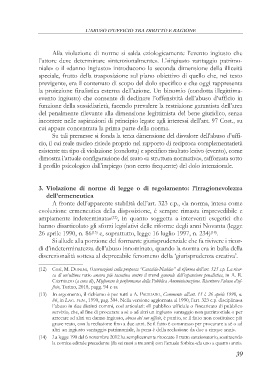Page 41 - Rassegna 2019-4
P. 41
L’ABUSO D’UFFICIO TRA DIRITTO E RAGIONE
Alla violazione di norme si salda eziologicamente l’evento ingiusto che
l’attore deve determinare «intenzionalmente». L’«ingiusto vantaggio patrimo-
niale» o il «danno ingiusto» introducono la seconda dimensione della illiceità
speciale, frutto della trasposizione sul piano obiettivo di quello che, nel testo
previgente, era il contenuto di scopo del dolo specifico e che oggi rappresenta
la proiezione finalistica esterna dell’azione. Un binomio (condotta illegittima-
evento ingiusto) che consente di declinare l’offensività dell’abuso d’ufficio in
funzione della sussidiarietà, facendo prevalere la restrizione garantista dell’area
del penalmente rilevante alla dimensione legittimista del bene giuridico, senza
incorrere nelle aspirazioni di principio legate agli interessi dell’art. 97 Cost., su
cui appare concentrata la prima parte della norma.
Su tali premesse si fonda la terza dimensione del disvalore dell’abuso d’uffi-
cio, il cui reale nucleo risiede proprio nel rapporto di reciproca complementarietà
esistente tra tipo di violazione (condotta) e specifico risultato lesivo (evento), come
dimostra l’attuale configurazione del reato «a struttura normativa», rafforzata sotto
il profilo psicologico dall’impiego (non certo frequente) del dolo intenzionale.
3. Violazione di norme di legge o di regolamento: l’irragionevolezza
dell’ermeneutica
A fronte dell’apparente stabilità dell’art. 323 c.p., «la norma, intesa come
evoluzione ermeneutica della disposizione, è sempre rimasta imprevedibile e
ampiamente indeterminata» , in quanto soggetta a interventi esegetici che
(12)
hanno disarticolato gli sforzi legislativi delle riforme degli anni Novanta (legge
26 aprile 1990, n. 86 e, soprattutto, legge 16 luglio 1997, n. 234) .
(13)
(14)
Si allude alla porzione del formante giurisprudenziale che fa rivivere i ricor-
di d’indeterminatezza dell’abuso innominato, quando la norma era in balia della
discrezionalità sottesa al deprecabile fenomeno della ‘giurisprudenza creativa’.
(12) Così, M. DONINI, Osservazioni sulla proposta “Castaldo-Naddeo” di riforma dell’art. 323 c.p. La ricer-
ca di un’ultima ratio ancora più tassativa contro il trend generale dell’espansione penalistica, in A. R.
CASTALDO (a cura di), Migliorare le performance della Pubblica Amministrazione. Riscrivere l’abuso d’uf-
ficio, Torino, 2018, pagg. 94 e ss.
(13) In argomento, il richiamo è per tutti a A. PAGLIARO, Commento all’art. 13 l. 26 aprile 1990, n.
86, in LEG. PEN., 1990, pag. 304. Nella versione aggiornata al 1990, l’art. 323 c.p. disciplinava
l’abuso in due distinti commi, così articolati: «Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico
servizio, che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per
arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio, è punito, se il fatto non costituisce più
grave reato, con la reclusione fino a due anni. Se il fatto è commesso per procurare a sé o ad
altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, la pena è della reclusione da due a cinque anni».
(14) La legge 190 del 6 novembre 2012 ha semplicemente ritoccato il tratto sanzionatorio, sostituendo
la cornice edittale precedente (da sei mesi a tre anni) con l’attuale forbice «da uno a quattro anni».
39