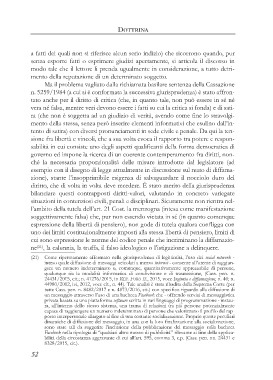Page 56 - Rassegna 2019-3
P. 56
DOTTRINA
a fatti dei quali non si riferisce alcun serio indizio) che ricorrono quando, pur
senza esporre fatti o esprimere giudizi apertamente, si articola il discorso in
modo tale che il lettore li prenda ugualmente in considerazione, a tutto detri-
mento della reputazione di un determinato soggetto.
Ma il problema vagliato dalla richiamata basilare sentenza della Cassazione
n. 5259/1984 (a cui si è conformata la successiva giurisprudenza) è stato affron-
tato anche per il diritto di critica (che, in quanto tale, non può essere in sé né
vera né falsa, mentre veri devono essere i fatti su cui la critica si fonda) e di sati-
ra (che non è soggetta ad un giudizio di verità, avendo come fine lo stravolgi-
mento della stessa, senza però inserire elementi informativi che esulino dall’in-
tento di satira) con diversi pronunciamenti in sede civile e penale. Da qui la ten-
sione fra libertà e vincoli, che a sua volta evoca il rapporto tra potere e respon-
sabilità in cui consiste uno degli aspetti qualificanti della forma democratica di
governo ed impone la ricerca di un coerente contemperamento fra diritti, non-
ché la necessaria proporzionalità delle misure introdotte dal legislatore (ad
esempio con il disegno di legge attualmente in discussione sul reato di diffama-
zione), stante l’insopprimibile esigenza di salvaguardare il nocciolo duro del
diritto, che di volta in volta deve recedere. È stato merito della giurisprudenza
bilanciare questi contrapposti diritti-valori, valutando in concreto variegate
situazioni in contenziosi civili, penali e disciplinari. Sicuramente non rientra nel-
l’ambito della tutela dell’art. 21 Cost. la menzogna (intesa come manifestazione
soggettivamente falsa) che, pur non essendo vietata in sé (in quanto comunque
espressione della libertà di pensiero), non gode di tutela qualora confligga con
uno dei limiti costituzionalmente imposti alla stessa libertà di pensiero, limiti di
cui sono espressione le norme del codice penale che incriminano la diffamazio-
ne , la calunnia, la truffa, il falso ideologico o l’istigazione a delinquere.
(21)
(21) Come ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità, l’uso dei social network -
inteso quale diffusione di messaggi veicolati a mezzo internet - consente all’utente di raggiun-
gere un numero indeterminato o, comunque, quantitativamente apprezzabile di persone,
qualunque sia la modalità informatica di condivisione e di trasmissione, (Cass. pen. n.
24431/2015, cit.; n. 41276/2015, in REP. FORO IT., 2015, voce Ingiuria e diffamazione, n. 40; n.
44980/2012, ivi, 2012, voce cit., n. 44). Tale analisi è stata ribadita dalla Suprema Corte (per
tutte Cass. pen. n. 8482/2017 e n. 4873/2016, cit.) con specifico riguardo alla diffusione di
un messaggio attraverso l’uso di una bacheca Facebook che - offrendo servizi di messaggistica
privata basata su una piattaforma software scritta in vari linguaggi di programmazione - instau-
ra, all’interno dello stesso sistema, una trama di relazioni tra più persone potenzialmente
capace di raggiungere un numero indeterminato di persone che valorizzano il profilo del rap-
porto interpersonale allargato al fine di una costante socializzazione. Proprio queste peculiari
dinamiche di diffusione del messaggio, in una con la loro finalizzazione alla socializzazione,
sono state tali da suggerire l’inclusione della pubblicazione del messaggio sulla bacheca
Facebook nella tipologia di “qualsiasi altro mezzo di pubblicità” rilevante ai fine della applica-
bilità della circostanza aggravante di cui all’art. 595, comma 3, c.p. (Cass. pen. nn. 24431 e
8328/2015, cit.).
52