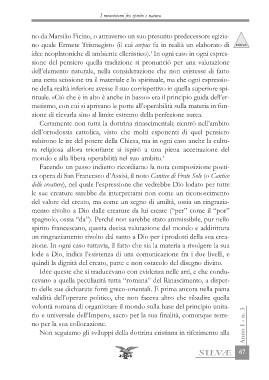Page 64 - SilvaeAnno01n03-005-Sommario-pagg.004.qxp
P. 64
I monoteismi fra spirito e natura
no da Marsilio Ficino, o attraverso un suo presunto predecessore egizia-
no quale Ermete Trismegisto (il cui corpus fu in realtà un elaborato di FOCUS
idee neoplatoniche di ambiente ellenistico). In ogni caso in ogni espres-
3
sione del pensiero quella tradizione si pronunciò per una valutazione
dell’elemento naturale, nella considerazione che non esistesse di fatto
una netta scissione tra il materiale e lo spirituale, ma che ogni espressio-
ne della realtà inferiore avesse il suo corrispettivo in quella superiore spi-
rituale. «Ciò che è in alto è anche in basso» era il principio guida dell’er-
metismo, con cui si aprivano le porte all’operabilità sulla materia in fun-
zione di elevarla sino al limite estremo della perfezione aurea.
Certamente non tutta la dottrina rinascimentale rientrò nell’ambito
dell’ortodossia cattolica, visto che molti esponenti di quel pensiero
subirono le ire del potere della Chiesa, ma in ogni caso anche la cultu-
ra religiosa allora trionfante si ispirò a una piena accettazione del
mondo e alla libera operabilità nel suo ambito. 4
Facendo un passo indietro ricordiamo la nota composizione poeti-
ca opera di San Francesco d’Assisi, il noto Cantico di Frate Sole (o Cantico
delle creature), nel quale l’espressione che vedrebbe Dio lodato per tutte
le sue creature sarebbe da interpretarsi non come un riconoscimento
del valore del creato, ma come un segno di umiltà, ossia un ringrazia-
mento rivolto a Dio dalle creature da lui create (“per” come il “por”
spagnolo, ossia “da”). Perché non sarebbe stato ammissibile, pur nello
spirito francescano, questa decisa valutazione del mondo e addirittura
un ringraziamento rivolto dal santo a Dio per i prodotti della sua crea-
zione. In ogni caso tuttavia, il fatto che sia la materia a rivolgere la sua
lode a Dio, indica l’esistenza di una comunicazione fra i due livelli, e
quindi la dignità del creato, parte e non ostacolo del disegno divino.
Idee queste che si traducevano con evidenza nelle arti, e che condu-
cevano a quella peculiarità tutta “romana” del Rinascimento, a dispet-
to delle sue dichiarate fonti greco-orientali. E prima ancora nella piena
validità dell’operare politico, che non faceva altro che ribadire quella
volontà romana di organizzare il mondo sulla base del principio unita-
rio e universale dell’Impero, sacro per la sua finalità, comunque terre- .3
no per la sua collocazione. oI-n
Non seguiamo gli sviluppi della dottrina cristiana in riferimento alla n
n
A
SILVÆ 67