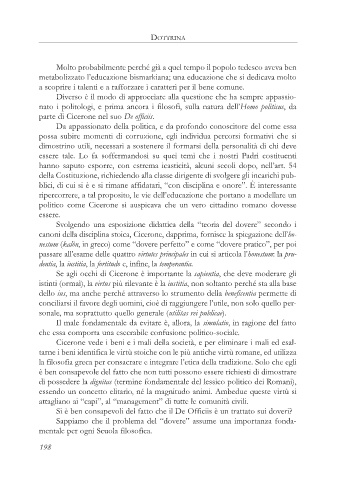Page 200 - Rassegna 2024-3
P. 200
DOTTRINA
Molto probabilmente perché già a quel tempo il popolo tedesco aveva ben
metabolizzato l’educazione bismarkiana; una educazione che si dedicava molto
a scoprire i talenti e a rafforzare i caratteri per il bene comune.
Diverso è il modo di approcciare alla questione che ha sempre appassio-
nato i politologi, e prima ancora i filosofi, sulla natura dell’Homo politicus, da
parte di Cicerone nel suo De officiis.
Da appassionato della politica, e da profondo conoscitore del come essa
possa subire momenti di corruzione, egli individua percorsi formativi che si
dimostrino utili, necessari a sostenere il formarsi della personalità di chi deve
essere tale. Lo fa soffermandosi su quei temi che i nostri Padri costituenti
hanno saputo esporre, con estrema icasticità, alcuni secoli dopo, nell’art. 54
della Costituzione, richiedendo alla classe dirigente di svolgere gli incarichi pub-
blici, di cui si è e si rimane affidatari, “con disciplina e onore”. È interessante
ripercorrere, a tal proposito, le vie dell’educazione che portano a modellare un
politico come Cicerone si auspicava che un vero cittadino romano dovesse
essere.
Svolgendo una esposizione didattica della “teoria del dovere” secondo i
canoni della disciplina stoica, Cicerone, dapprima, fornisce la spiegazione dell’ho-
nestum (kalòn, in greco) come “dovere perfetto” e come “dovere pratico”, per poi
passare all’esame delle quattro virtutes principales in cui si articola l’honestum: la pru-
dentia, la iustitia, la fortitudo e, infine, la temperantia.
Se agli occhi di Cicerone è importante la sapientia, che deve moderare gli
istinti (ormaì), la virtus più rilevante è la iustitia, non soltanto perché sta alla base
dello ius, ma anche perché attraverso lo strumento della beneficentia permette di
conciliarsi il favore degli uomini, cioè di raggiungere l’utile, non solo quello per-
sonale, ma soprattutto quello generale (utilitas rei publicae).
Il male fondamentale da evitare è, allora, la simulatio, in ragione del fatto
che essa comporta una esecrabile confusione politico-sociale.
Cicerone vede i beni e i mali della società, e per eliminare i mali ed esal-
tarne i beni identifica le virtù stoiche con le più antiche virtù romane, ed utilizza
la filosofia greca per consacrare e integrare l’etica della tradizione. Solo che egli
è ben consapevole del fatto che non tutti possono essere richiesti di dimostrare
di possedere la dignitas (termine fondamentale del lessico politico dei Romani),
essendo un concetto elitario, né la magnitudo animi. Ambedue queste virtù si
attagliano ai “capi”, al “management” di tutte le comunità civili.
Si è ben consapevoli del fatto che il De Officiis è un trattato sui doveri?
Sappiamo che il problema del “dovere” assume una importanza fonda-
mentale per ogni Scuola filosofica.
198