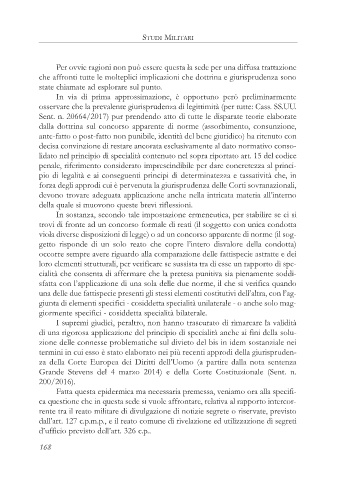Page 170 - Rassegna 2024-1
P. 170
STUDI MILITARI
Per ovvie ragioni non può essere questa la sede per una diffusa trattazione
che affronti tutte le molteplici implicazioni che dottrina e giurisprudenza sono
state chiamate ad esplorare sul punto.
In via di prima approssimazione, è opportuno però preliminarmente
osservare che la prevalente giurisprudenza di legittimità (per tutte: Cass. SS.UU.
Sent. n. 20664/2017) pur prendendo atto di tutte le disparate teorie elaborate
dalla dottrina sul concorso apparente di norme (assorbimento, consunzione,
ante-fatto o post-fatto non punibile, identità del bene giuridico) ha ritenuto con
decisa convinzione di restare ancorata esclusivamente al dato normativo conso-
lidato nel principio di specialità contenuto nel sopra riportato art. 15 del codice
penale, riferimento considerato imprescindibile per dare concretezza al princi-
pio di legalità e ai conseguenti principi di determinatezza e tassatività che, in
forza degli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza delle Corti sovranazionali,
devono trovare adeguata applicazione anche nella intricata materia all’interno
della quale si muovono queste brevi riflessioni.
In sostanza, secondo tale impostazione ermeneutica, per stabilire se ci si
trovi di fronte ad un concorso formale di reati (il soggetto con unica condotta
viola diverse disposizioni di legge) o ad un concorso apparente di norme (il sog-
getto risponde di un solo reato che copre l’intero disvalore della condotta)
occorre sempre avere riguardo alla comparazione delle fattispecie astratte e dei
loro elementi strutturali, per verificare se sussista tra di esse un rapporto di spe-
cialità che consenta di affermare che la pretesa punitiva sia pienamente soddi-
sfatta con l’applicazione di una sola delle due norme, il che si verifica quando
una delle due fattispecie presenti gli stessi elementi costitutivi dell’altra, con l’ag-
giunta di elementi specifici - cosiddetta specialità unilaterale - o anche solo mag-
giormente specifici - cosiddetta specialità bilaterale.
I supremi giudici, peraltro, non hanno trascurato di rimarcare la validità
di una rigorosa applicazione del principio di specialità anche ai fini della solu-
zione delle connesse problematiche sul divieto del bis in idem sostanziale nei
termini in cui esso è stato elaborato nei più recenti approdi della giurispruden-
za della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (a partire dalla nota sentenza
Grande Stevens del 4 marzo 2014) e della Corte Costituzionale (Sent. n.
200/2016).
Fatta questa epidermica ma necessaria premessa, veniamo ora alla specifi-
ca questione che in questa sede si vuole affrontare, relativa al rapporto intercor-
rente tra il reato militare di divulgazione di notizie segrete o riservate, previsto
dall’art. 127 c.p.m.p., e il reato comune di rivelazione ed utilizzazione di segreti
d’ufficio previsto dell’art. 326 c.p..
168