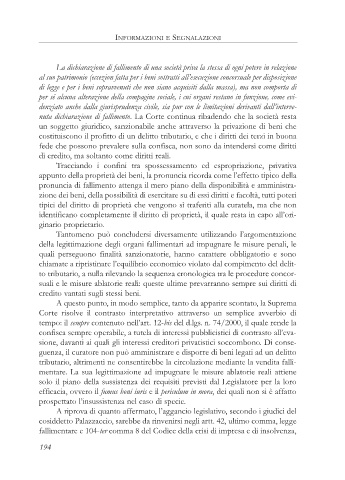Page 196 - Rassegna 2023-4
P. 196
INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI
La dichiarazione di fallimento di una società priva la stessa di ogni potere in relazione
al suo patrimonio (eccezion fatta per i beni sottratti all’esecuzione concorsuale per disposizione
di legge e per i beni sopravvenuti che non siano acquisiti dalla massa), ma non comporta di
per sé alcuna alterazione della compagine sociale, i cui organi restano in funzione, come evi-
denziato anche dalla giurisprudenza civile, sia pur con le limitazioni derivanti dall’interve-
nuta dichiarazione di fallimento. La Corte continua ribadendo che la società resta
un soggetto giuridico, sanzionabile anche attraverso la privazione di beni che
costituiscono il profitto di un delitto tributario, e che i diritti dei terzi in buona
fede che possono prevalere sulla confisca, non sono da intendersi come diritti
di credito, ma soltanto come diritti reali.
Tracciando i confini tra spossessamento ed espropriazione, privativa
appunto della proprietà dei beni, la pronuncia ricorda come l’effetto tipico della
pronuncia di fallimento attenga il mero piano della disponibilità e amministra-
zione dei beni, della possibilità di esercitare su di essi diritti e facoltà, tutti poteri
tipici del diritto di proprietà che vengono sì traferiti alla curatela, ma che non
identificano completamente il diritto di proprietà, il quale resta in capo all’ori-
ginario proprietario.
Tantomeno può concludersi diversamente utilizzando l’argomentazione
della legittimazione degli organi fallimentari ad impugnare le misure penali, le
quali perseguono finalità sanzionatorie, hanno carattere obbligatorio e sono
chiamate a ripristinare l’equilibrio economico violato dal compimento del delit-
to tributario, a nulla rilevando la sequenza cronologica tra le procedure concor-
suali e le misure ablatorie reali: queste ultime prevarranno sempre sui diritti di
credito vantati sugli stessi beni.
A questo punto, in modo semplice, tanto da apparire scontato, la Suprema
Corte risolve il contrasto interpretativo attraverso un semplice avverbio di
tempo: il sempre contenuto nell’art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000, il quale rende la
confisca sempre operabile, a tutela di interessi pubblicistici di contrasto all’eva-
sione, davanti ai quali gli interessi creditori privatistici soccombono. Di conse-
guenza, il curatore non può amministrare e disporre di beni legati ad un delitto
tributario, altrimenti ne consentirebbe la circolazione mediante la vendita falli-
mentare. La sua legittimazione ad impugnare le misure ablatorie reali attiene
solo il piano della sussistenza dei requisiti previsti dal Legislatore per la loro
efficacia, ovvero il fumus boni iuris e il periculum in mora, dei quali non si è affatto
prospettato l’insussistenza nel caso di specie.
A riprova di quanto affermato, l’aggancio legislativo, secondo i giudici del
cosiddetto Palazzaccio, sarebbe da rinvenirsi negli artt. 42, ultimo comma, legge
fallimentare e 104-ter comma 8 del Codice della crisi di impresa e di insolvenza,
194