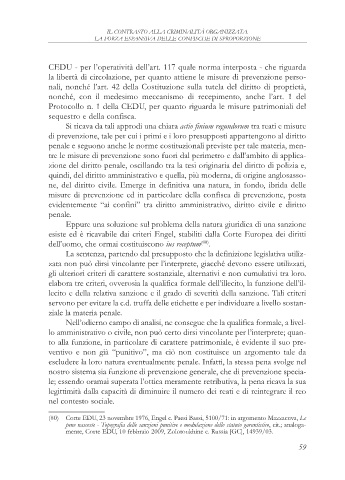Page 61 - Rassegna 2023-2
P. 61
IL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.
LA FORZA ESPANSIVA DELLE CONFISCHE DI SPROPORZIONE
CEDU - per l’operatività dell’art. 117 quale norma interposta - che riguarda
la libertà di circolazione, per quanto attiene le misure di prevenzione perso-
nali, nonché l’art. 42 della Costituzione sulla tutela del diritto di proprietà,
nonché, con il medesimo meccanismo di recepimento, anche l’art. 1 del
Protocollo n. 1 della CEDU, per quanto riguarda le misure patrimoniali del
sequestro e della confisca.
Si ricava da tali approdi una chiara actio finium regundorum tra reati e misure
di prevenzione, tale per cui i primi e i loro presupposti appartengono al diritto
penale e seguono anche le norme costituzionali previste per tale materia, men-
tre le misure di prevenzione sono fuori dal perimetro e dall’ambito di applica-
zione del diritto penale, oscillando tra la tesi originaria del diritto di polizia e,
quindi, del diritto amministrativo e quella, più moderna, di origine anglosasso-
ne, del diritto civile. Emerge in definitiva una natura, in fondo, ibrida delle
misure di prevenzione ed in particolare della confisca di prevenzione, posta
evidentemente “ai confini” tra diritto amministrativo, diritto civile e diritto
penale.
Eppure una soluzione sul problema della natura giuridica di una sanzione
esiste ed è ricavabile dai criteri Engel, stabiliti dalla Corte Europea dei diritti
(80)
dell’uomo, che ormai costituiscono ius receptum .
La sentenza, partendo dal presupposto che la definizione legislativa utiliz-
zata non può dirsi vincolante per l’interprete, giacché devono essere utilizzati,
gli ulteriori criteri di carattere sostanziale, alternativi e non cumulativi tra loro.
elabora tre criteri, ovverosia la qualifica formale dell’illecito, la funzione dell’il-
lecito e della relativa sanzione e il grado di severità della sanzione. Tali criteri
servono per evitare la c.d. truffa delle etichette e per individuare a livello sostan-
ziale la materia penale.
Nell’odierno campo di analisi, ne consegue che la qualifica formale, a livel-
lo amministrativo o civile, non può certo dirsi vincolante per l’interprete; quan-
to alla funzione, in particolare di carattere patrimoniale, è evidente il suo pre-
ventivo e non già “punitivo”, ma ciò non costituisce un argomento tale da
escludere la loro natura eventualmente penale. Infatti, la stessa pena svolge nel
nostro sistema sia funzione di prevenzione generale, che di prevenzione specia-
le; essendo oramai superata l’ottica meramente retributiva, la pena ricava la sua
legittimità dalla capacità di diminuire il numero dei reati e di reintegrare il reo
nel contesto sociale.
(80) Corte EDU, 23 novembre 1976, Engel c. Paesi Bassi, 5100/71: in argomento Mazzacuva, Le
pene nascoste - Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico, cit.; analoga-
mente, Corte EDU, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine c. Russia [GC], 14939/03.
59