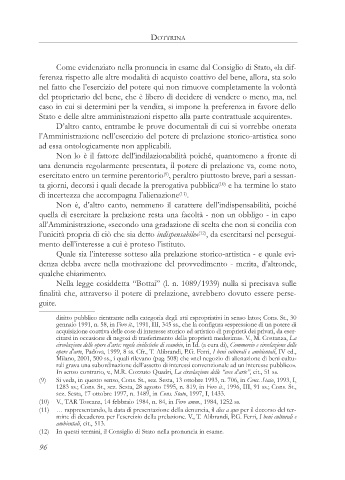Page 98 - Rassegna 2023-1
P. 98
DOTTRINA
Come evidenziato nella pronuncia in esame dal Consiglio di Stato, «la dif-
ferenza rispetto alle altre modalità di acquisto coattivo del bene, allora, sta solo
nel fatto che l’esercizio del potere qui non rimuove completamente la volontà
del proprietario del bene, che è libero di decidere di vendere o meno, ma, nel
caso in cui si determini per la vendita, si impone la preferenza in favore dello
Stato e delle altre amministrazioni rispetto alla parte contrattuale acquirente».
D’altro canto, entrambe le prove documentali di cui si vorrebbe onerata
l’Amministrazione nell’esercizio del potere di prelazione storico-artistica sono
ad essa ontologicamente non applicabili.
Non lo è il fattore dell’indilazionabilità poiché, quantomeno a fronte di
una denuncia regolarmente presentata, il potere di prelazione va, come noto,
esercitato entro un termine perentorio , peraltro piuttosto breve, pari a sessan-
(9)
ta giorni, decorsi i quali decade la prerogativa pubblica e ha termine lo stato
(10)
di incertezza che accompagna l’alienazione .
(11)
Non è, d’altro canto, nemmeno il carattere dell’indispensabilità, poiché
quella di esercitare la prelazione resta una facoltà - non un obbligo - in capo
all’Amministrazione, «secondo una gradazione di scelta che non si concilia con
l’unicità propria di ciò che sia detto indispensabile» , da esercitarsi nel persegui-
(12)
mento dell’interesse a cui è proteso l’istituto.
Quale sia l’interesse sotteso alla prelazione storico-artistica - e quale evi-
denza debba avere nella motivazione del provvedimento - merita, d’altronde,
qualche chiarimento.
Nella legge cosiddetta “Bottai” (l. n. 1089/1939) nulla si precisava sulle
finalità che, attraverso il potere di prelazione, avrebbero dovuto essere perse-
guite.
diritto pubblico rientrante nella categoria degli atti espropriativi in senso lato»; Cons. St., 30
gennaio 1991, n. 58, in Foro it., 1991, III, 345 ss., che la configura «espressione di un potere di
acquisizione coattiva delle cose di interesse storico ed artistico di proprietà dei privati, da eser-
citarsi in occasione di negozi di trasferimento della proprietà medesima». V., M. Costanza, La
circolazione delle opere d’arte: regole civilistiche di scambio, in Id. (a cura di), Commercio e circolazione delle
opere d’arte, Padova, 1999, 8 ss. Cfr., T. Alibrandi, P.G. Ferri, I beni culturali e ambientali, IV ed.,
Milano, 2001, 500 ss., i quali rilevano (pag. 508) che «nel negozio di alienazione di beni cultu-
rali grava una subordinazione dell’assetto di interessi convenzionale ad un interesse pubblico».
In senso contrario, v., M.R. Cozzuto Quadri, La circolazione delle “cose d’arte”, cit., 51 ss.
(9) Si veda, in questo senso, Cons. St., sez. Sesta, 13 ottobre 1993, n. 706, in Cons. Stato, 1993, I,
1283 ss.; Cons. St., sez. Sesta, 28 agosto 1995, n. 819, in Foro it., 1996, III, 91 ss.; Cons. St.,
sez. Sesta, 17 ottobre 1997, n. 1489, in Cons. Stato, 1997, I, 1433.
(10) V., TAR Toscana, 14 febbraio 1984, n. 84, in Foro amm., 1984, 1252 ss.
(11) … rappresentando, la data di presentazione della denuncia, il dies a quo per il decorso del ter-
mine di decadenza per l’esercizio della prelazione. V., T. Alibrandi, P.G. Ferri, I beni culturali e
ambientali, cit., 513.
(12) In questi termini, il Consiglio di Stato nella pronuncia in esame.
96