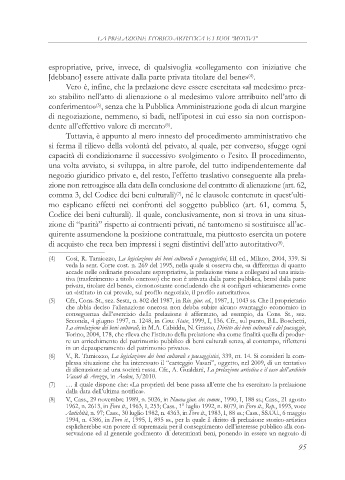Page 97 - Rassegna 2023-1
P. 97
LA PRELAZIONE STORICO-ARTISTICA E I SUOI “MOTIVI”
espropriative, prive, invece, di qualsivoglia «collegamento con iniziative che
[debbano] essere attivate dalla parte privata titolare del bene» .
(4)
Vero è, infine, che la prelazione deve essere esercitata «al medesimo prez-
zo stabilito nell’atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell’atto di
conferimento» , senza che la Pubblica Amministrazione goda di alcun margine
(5)
di negoziazione, nemmeno, si badi, nell’ipotesi in cui esso sia non corrispon-
dente all’effettivo valore di mercato .
(6)
Tuttavia, è appunto al mero innesto del procedimento amministrativo che
si ferma il rilievo della volontà del privato, al quale, per converso, sfugge ogni
capacità di condizionarne il successivo svolgimento o l’esito. Il procedimento,
una volta avviato, si sviluppa, in altre parole, del tutto indipendentemente dal
negozio giuridico privato e, del resto, l’effetto traslativo conseguente alla prela-
zione non retroagisce alla data della conclusione del contratto di alienazione (art. 62,
comma 3, del Codice dei beni culturali) , né le clausole contenute in quest’ulti-
(7)
mo esplicano effetti nei confronti del soggetto pubblico (art. 61, comma 5,
Codice dei beni culturali). Il quale, conclusivamente, non si trova in una situa-
zione di “parità” rispetto ai contraenti privati, né tantomeno si sostituisce all’ac-
quirente assumendone la posizione contrattuale, ma piuttosto esercita un potere
di acquisto che reca ben impressi i segni distintivi dell’atto autoritativo .
(8)
(4) Così, R. Tamiozzo, La legislazione dei beni culturali e paesaggistici, III ed., Milano, 2004, 339. Si
veda la sent. Corte cost. n. 269 del 1995, nella quale si osserva che, «a differenza di quanto
accade nelle ordinarie procedure espropriative, la prelazione viene a collegarsi ad una inizia-
tiva (trasferimento a titolo oneroso) che non è attivata dalla parte pubblica, bensì dalla parte
privata, titolare del bene», ciononostante concludendo che si configuri «chiaramente» come
un «istituto in cui prevale, sul profilo negoziale, il profilo autoritativo».
(5) Cfr., Cons. St., sez. Sesta, n. 802 del 1987, in Riv. giur. ed., 1987, I, 1043 ss. Che il proprietario
che abbia deciso l’alienazione onerosa non debba subire alcuno svantaggio economico in
conseguenza dell’esercizio della prelazione è affermato, ad esempio, da Cons. St., sez.
Seconda, 4 giugno 1997, n. 1248, in Cons. Stato, 1999, I, 136. Cfr., sul punto, B.L. Boschetti,
La circolazione dei beni culturali, in M.A. Cabiddu, N. Grasso, Diritto dei beni culturali e del paesaggio,
Torino, 2004, 178, che rileva che l’istituto della prelazione «ha come finalità quella di produr-
re un arricchimento del patrimonio pubblico di beni culturali senza, al contempo, riflettersi
in un depauperamento del patrimonio privato».
(6) V., R. Tamiozzo, La legislazione dei beni culturali e paesaggistici, 339, nt. 14. Si consideri la com-
plessa situazione che ha interessato il “carteggio Vasari”, oggetto, nel 2009, di un tentativo
di alienazione ad una società russa. Cfr., A. Gualdani, La prelazione artistica e il caso dell’archivio
Vasari di Arezzo, in Aedon, 3/2010.
(7) … il quale dispone che: «La proprietà del bene passa all’ente che ha esercitato la prelazione
dalla data dell’ultima notifica».
(8) V., Cass., 29 novembre 1989, n. 5026, in Nuova giur. civ. comm., 1990, I, 188 ss.; Cass., 21 agosto
1962, n. 2613, in Foro it., 1963, I, 253; Cass., 1° luglio 1992, n. 8079, in Foro it., Rep., 1993, voce
Antichità, n. 97; Cass., 30 luglio 1982, n. 4363, in Foro it., 1983, I, 88 ss.; Cass., SS.UU., 6 maggio
1994, n. 4386, in Foro it., 1995, I, 895 ss., per la quale il diritto di prelazione storico-artistica
esplicherebbe «un potere di supremazia per il conseguimento dell’interesse pubblico alla con-
servazione ed al generale godimento di determinati beni, ponendo in essere un negozio di
95