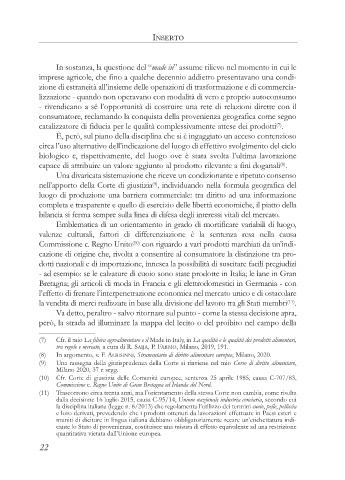Page 24 - Rassegna 2022-1_inserto
P. 24
INSERTO
In sostanza, la questione del “made in” assume rilievo nel momento in cui le
imprese agricole, che fino a qualche decennio addietro presentavano una condi-
zione di estraneità all’insieme delle operazioni di trasformazione e di commercia-
lizzazione - quando non operavano con modalità di vero e proprio autoconsumo
- rivendicano a sé l’opportunità di costruire una rete di relazioni dirette con il
consumatore, reclamando la conquista della provenienza geografica come segno
catalizzatore di fiducia per le qualità complessivamente attese dei prodotti .
(7)
È, però, sul piano della disciplina che si è ingaggiato un acceso contenzioso
circa l’uso alternativo dell’indicazione del luogo di effettivo svolgimento del ciclo
biologico e, rispettivamente, del luogo ove è stata svolta l’ultima lavorazione
capace di attribuire un valore aggiunto al prodotto rilevante a fini doganali .
(8)
Una divaricata sistemazione che riceve un condizionante e ripetuto consenso
nell’apporto della Corte di giustizia , individuando nella formula geografica del
(9)
luogo di produzione una barriera commerciale: tra diritto ad una informazione
completa e trasparente e quello di esercizio delle libertà economiche, il piatto della
bilancia si ferma sempre sulla linea di difesa degli interessi vitali del mercato.
Emblematica di un orientamento in grado di mortificare variabili di luogo,
valenze culturali, fattori di differenziazione è la sentenza resa nella causa
Commissione c. Regno Unito con riguardo a vari prodotti marchiati da un’indi-
(10)
cazione di origine che, rivolta a consentire al consumatore la distinzione tra pro-
dotti nazionali e di importazione, innesca la possibilità di suscitare facili pregiudizi
- ad esempio: se le calzature di cuoio sono state prodotte in Italia; le lane in Gran
Bretagna; gli articoli di moda in Francia e gli elettrodomestici in Germania - con
l’effetto di frenare l’interpenetrazione economica nel mercato unico e di ostacolare
la vendita di merci realizzate in base alla divisione del lavoro tra gli Stati membri .
(11)
Va detto, peraltro - salvo ritornare sul punto - come la stessa decisione apra,
però, la strada ad illuminare la mappa del lecito o del proibito nel campo della
(7) Cfr. il mio La filiera agroalimentare e il Made in Italy, in La qualità e le qualità dei prodotti alimentari,
tra regole e mercato, a cura di R. SAIJA, P. FABBIO, Milano, 2019, 191.
(8) In argomento, v. F. ALBISINNI, Strumentario di diritto alimentare europeo, Milano, 2020.
(9) Una rassegna della giurisprudenza della Corte si rinviene nel mio Corso di diritto alimentare,
Milano 2020, 37 e segg.
(10) Cfr. Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza 25 aprile 1985, causa C-707/83,
Commissione c. Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord.
(11) Trascorrono circa trenta anni, ma l’orientamento della stessa Corte non cambia, come risulta
dalla decisione 16 luglio 2015, causa C-95/14, Unione nazionale industria conciaria, secondo cui
la disciplina italiana (legge n. 8/2013) che regolamenta l’utilizzo dei termini cuoio, pelle, pelliccia
e loro derivati, prevedendo che i prodotti ottenuti da lavorazioni effettuate in Paesi esteri e
muniti di diciture in lingua italiana debbano obbligatoriamente recare un’etichettatura indi-
cante lo Stato di provenienza, costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione
quantitativa vietata dall’Unione europea.
22