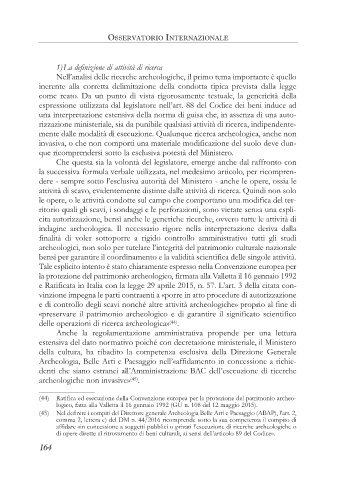Page 166 - Rassegna 2021-4
P. 166
OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
1)La definizione di attività di ricerca
Nell’analisi delle ricerche archeologiche, il primo tema importante è quello
inerente alla corretta delimitazione della condotta tipica prevista dalla legge
come reato. Da un punto di vista rigorosamente testuale, la genericità della
espressione utilizzata dal legislatore nell’art. 88 del Codice dei beni induce ad
una interpretazione estensiva della norma di guisa che, in assenza di una auto-
rizzazione ministeriale, sia da punibile qualsiasi attività di ricerca, indipendente-
mente dalle modalità di esecuzione. Qualunque ricerca archeologica, anche non
invasiva, o che non comporti una materiale modificazione del suolo deve dun-
que ricomprendersi sotto la esclusiva potestà del Ministero.
Che questa sia la volontà del legislatore, emerge anche dal raffronto con
la successiva formula verbale utilizzata, nel medesimo articolo, per ricompren-
dere - sempre sotto l’esclusiva autorità del Ministero - anche le opere, ossia le
attività di scavo, evidentemente distinte dalle attività di ricerca. Quindi non solo
le opere, o le attività condotte sul campo che comportano una modifica del ter-
ritorio quali gli scavi, i sondaggi e le perforazioni, sono vietate senza una espli-
cita autorizzazione, bensì anche le generiche ricerche, ovvero tutte le attività di
indagine archeologica. Il necessario rigore nella interpretazione deriva dalla
finalità di voler sottoporre a rigido controllo amministrativo tutti gli studi
archeologici, non solo per tutelare l’integrità del patrimonio culturale nazionale
bensì per garantire il coordinamento e la validità scientifica delle singole attività.
Tale esplicito intento è stato chiaramente espresso nella Convenzione europea per
la protezione del patrimonio archeologico, firmata alla Valletta il 16 gennaio 1992
e Ratificata in Italia con la legge 29 aprile 2015, n. 57. L’art. 3 della citata con-
vinzione impegna le parti contraenti a «porre in atto procedure di autorizzazione
e di controllo degli scavi nonché altre attività archeologiche» proprio al fine di
«preservare il patrimonio archeologico e di garantire il significato scientifico
delle operazioni di ricerca archeologica» .
(44)
Anche la regolamentazione amministrativa propende per una lettura
estensiva del dato normativo poiché con decretazione ministeriale, il Ministero
della cultura, ha ribadito la competenza esclusiva della Direzione Generale
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio nell’«affidamento in concessione a richie-
denti che siano estranei all’Amministrazione BAC dell’esecuzione di ricerche
(45)
archeologiche non invasive» .
(44) Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeo-
logico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992 (GU n. 108 del 12 maggio 2015).
(45) Nel definire i compiti del Direttore generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (ABAP), l’art. 2,
comma 2, lettera e) del DM n. 44/2016 ricomprende sotto la sua competenza il compito di
affidare «in concessione a soggetti pubblici o privati l’esecuzione di ricerche archeologiche o
di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell’articolo 89 del Codice».
164