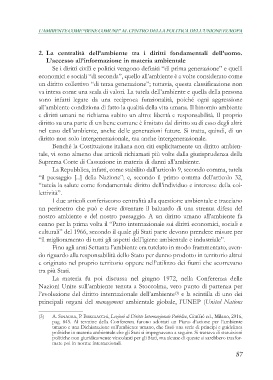Page 89 - Rassegna 2020-1
P. 89
L’AMBIENTE COME “BENE COMUNE” AL CENTRO DELLA POLITICA DELL’UNIONE EUROPA
2. La centralità dell’ambiente tra i diritti fondamentali dell’uomo.
L’accesso all’informazione in materia ambientale
Se i diritti civili e politici vengono definiti “di prima generazione” e quelli
economici e sociali “di seconda”, quello all’ambiente è a volte considerato come
un diritto collettivo “di terza generazione”; tuttavia, questa classificazione non
va intesa come una scala di valori. La tutela dell’ambiente e quella della persona
sono infatti legate da una reciproca funzionalità, poiché ogni aggressione
all’ambiente condiziona di fatto la qualità della vita umana. Il binomio ambiente
e diritti umani ne richiama subito un altro: libertà e responsabilità. Il proprio
diritto su una parte di un bene comune è limitato dal diritto su di esso degli altri:
nel caso dell’ambiente, anche delle generazioni future. Si tratta, quindi, di un
diritto non solo intergenerazionale, ma anche intergenerazionale.
Benché la Costituzione italiana non citi esplicitamente un diritto ambien-
tale, vi sono almeno due articoli richiamati più volte dalla giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione in materia di danni all’ambiente.
La Repubblica, infatti, come stabilito dall’articolo 9, secondo comma, tutela
“il paesaggio [...] della Nazione”; e, secondo il primo comma dell’articolo 32,
“tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della col-
lettività”.
I due articoli conferiscono centralità alla questione ambientale e tracciano
un perimetro che può e deve diventare il baluardo di una strenua difesa del
nostro ambiente e del nostro paesaggio. A un diritto umano all’ambiente fa
cenno per la prima volta il “Patto internazionale sui diritti economici, sociali e
culturali” del 1966, secondo il quale gli Stati parte devono prendere misure per
“il miglioramento di tutti gli aspetti dell’igiene ambientale e industriale”.
Fino agli anni Settanta l’ambiente era tutelato in modo frammentato, aven-
do riguardo alla responsabilità dello Stato per danno prodotto in territorio altrui
e originato nel proprio territorio oppure nell’utilizzo dei fiumi che scorrevano
tra più Stati.
La materia fu poi discussa nel giugno 1972, nella Conferenza delle
Nazioni Unite sull’ambiente tenuta a Stoccolma, vero punto di partenza per
l’evoluzione del diritto internazionale dell’ambiente e la scintilla di uno dei
(3)
principali organi del management ambientale globale, l’UNEP (United Nations
(3) A. SINAGRA, P. BARGIACCHi, Lezioni di Diritto Internazionale Pubblico, Giuffrè ed., Milano, 2016,
pag. 845. Al termine della Conferenza furono adottati un Piano d’azione per l’ambiente
umano e una Dichiarazione sull’ambiente umano, che fissò una serie di principi e guidelines
politiche in materia ambientale che gli Stati si impegnavano a seguire. Si trattava di statuizioni
politiche non giuridicamente vincolanti per gli Stati, ma alcune di queste si sarebbero trasfor-
mate poi in norme internazionali.
87