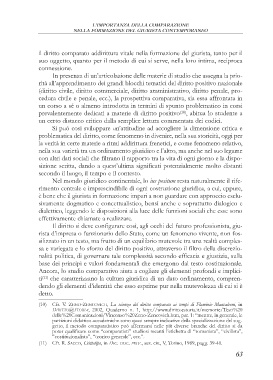Page 65 - Rassegna 2020-1
P. 65
L’IMPORTANZA DELLA COMPARAZIONE
NELLA FORMAZIONE DEL GIURISTA CONTEMPORANEO
il diritto comparato addirittura vitale nella formazione del giurista, tanto per il
suo oggetto, quanto per il metodo di cui si serve, nella loro intima, reciproca
connessione.
In presenza di un’articolazione delle materie di studio che assegna la prio-
rità all’apprendimento dei grandi blocchi tematici del diritto positivo nazionale
(diritto civile, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto penale, pro-
cedura civile e penale, ecc.), la prospettiva comparativa, sia essa affrontata in
un corso a sé o almeno introdotta in termini di spunto problematico in corsi
prevalentemente dedicati a materie di diritto positivo , abitua lo studente a
(10)
un certo distacco critico dalla semplice lettura commentata dei codici.
Si può così sviluppare un’attitudine ad accogliere la dimensione critica e
problematica del diritto, come fenomeno in divenire, nella sua storicità, oggi per
la verità in certe materie a ritmi addirittura frenetici, e come fenomeno relativo,
nella sua varietà tra un ordinamento giuridico e l’altro, ma anche nel suo legame
con altri dati sociali che filtrano il rapporto tra la vita di ogni giorno e la dispo-
sizione scritta, dando a quest’ultima significati potenzialmente molto distanti
secondo il luogo, il tempo e il contesto.
Nel mondo giuridico continentale, lo ius positum resta naturalmente il rife-
rimento centrale e imprescindibile di ogni costruzione giuridica, a cui, eppure,
è bene che il giurista in formazione impari a non guardare con approccio esclu-
sivamente dogmatico e concettualistico, bensì anche e soprattutto dialogico e
dialettico, leggendo le disposizioni alla luce delle funzioni sociali che esse sono
effettivamente chiamate a realizzare.
Il diritto si deve configurare così, agli occhi del futuro professionista, giu-
rista d’impresa o funzionario dello Stato, come un fenomeno vivente, non fos-
silizzato in un testo, ma frutto di un equilibrio mutevole tra una realtà comples-
sa e variegata e lo sforzo del diritto positivo, attraverso il filtro della discrezio-
nalità politica, di governare tale complessità secondo efficacia e giustizia, sulla
base dei principi e valori fondamentali che emergono dal testo costituzionale.
Ancora, lo studio comparativo aiuta a cogliere gli elementi profondi e implici-
ti che caratterizzano la cultura giuridica di un dato ordinamento, compren-
(11)
dendo gli elementi d’identità che esso esprime pur nella mutevolezza di cui si è
detto.
(10) Cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, La scienza del diritto comparato ai tempi di Flaminio Mancaleoni, in
DIRITTO@STORIA, 2002, Quaderno n. 1, http://www.dirittoestoria.it/memorie/Testi%20
delle%20Comunicazioni/Vincenzo%20Zeno-Zencovich.htm, par. 1: “mentre, in generale, le
partizioni didattico-accademiche sono quasi sempre indicative della specializzazione del sog-
getto, il metodo comparatistico può affermarsi nelle più diverse branche del diritto sì da
poter qualificare come “comparatisti” studiosi recanti l’etichetta di “romanista”, “civilista”,
“costituzionalista”, “teorico generale”, ecc.”.
(11) Cfr. R. SACCO, Crittotipo, in DIG. DISC. PRIV., sez. civ., V, Torino, 1989, pagg. 39-40.
63