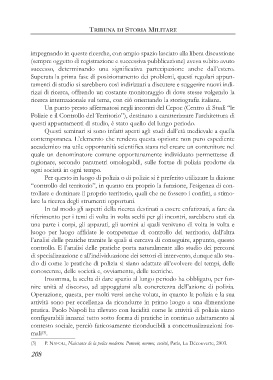Page 210 - Rassegna 2020-1
P. 210
TRIBUNA DI STORIA MILITARE
impegnando in queste ricerche, con ampio spazio lasciato alla libera discussione
(sempre oggetto di registrazione e successiva pubblicazione) aveva subito avuto
successo, determinando una significativa partecipazione anche dall’estero.
Superata la prima fase di posizionamento dei problemi, questi regolari appun-
tamenti di studio si sarebbero così indirizzati a discutere e suggerire nuovi indi-
rizzi di ricerca, offrendo un costante monitoraggio di dove stesse volgendo la
ricerca internazionale sul tema, con ciò orientando la storiografia italiana.
Un punto presto affermatosi negli incontri del Cepoc (Centro di Studi “le
Polizie e il Controllo del Territorio”), destinato a caratterizzare l’architettura di
questi appuntamenti di studio, è stato quello del lungo periodo.
Questi seminari si sono infatti aperti agli studi dall’età medievale a quella
contemporanea. L’elemento che rendeva questa opzione non puro espediente
accademico ma utile opportunità scientifica stava nel creare un contenitore nel
quale un denominatore comune opportunamente individuato permettesse di
ragionare, secondo parametri omologabili, sulle forme di polizia prodotte da
ogni società in ogni tempo.
Per questo in luogo di polizia o di polizie si è preferito utilizzare la dizione
“controllo del territorio”, in quanto era proprio la funzione, l’esigenza di con-
trollare e dominare il proprio territorio, quali che ne fossero i confini, a stimo-
lare la ricerca degli strumenti opportuni.
In tal modo gli aspetti della ricerca destinati a essere enfatizzati, a fare da
riferimento per i temi di volta in volta scelti per gli incontri, sarebbero stati da
una parte i corpi, gli apparati, gli uomini ai quali venivano di volta in volta e
luogo per luogo affidate le competenze di controllo del territorio, dall’altra
l’analisi delle pratiche tramite le quali si cercava di conseguire, appunto, questo
controllo. E l’analisi delle pratiche porta naturalmente allo studio dei percorsi
di specializzazione e all’individuazione dei settori di intervento, dunque allo stu-
dio di come le pratiche di polizia si siano adattate all’evolvere dei tempi, delle
conoscenze, delle società e, ovviamente, delle tecniche.
Insomma, la scelta di dare spazio al lungo periodo ha obbligato, per for-
nire unità al discorso, ad appoggiarsi alla concretezza dell’azione di polizia.
Operazione, questa, per molti versi anche voluta, in quanto la polizia e la sua
attività sono per eccellenza da ricondurre in primo luogo a una dimensione
pratica. Paolo Napoli ha rilevato con lucidità come le attività di polizia siano
configurabili innanzi tutto sotto forma di pratiche in continuo adattamento al
contesto sociale, perciò faticosamente riconducibili a concettualizzazioni for-
mali .
(3)
(3) P. NAPOLI, Naissance de la police moderne. Pouvoir, normes, société, Paris, La Découverte, 2003.
208