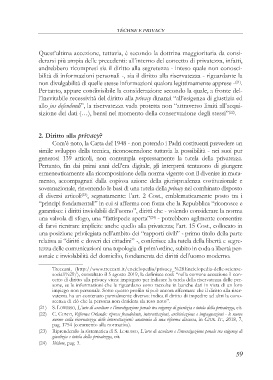Page 61 - Rassegna 2019-4
P. 61
TÉCHNE E PRIVACY
Quest’ultima accezione, tuttavia, è secondo la dottrina maggioritaria da consi-
derarsi più ampia delle precedenti: all’interno del concetto di privatezza, infatti,
andrebbero ricompresi sia il diritto alla segretezza - inteso quale non conosci-
bilità di informazioni personali -, sia il diritto alla riservatezza - riguardante la
non divulgabilità di quelle stesse informazioni qualora legittimamente apprese - .
(21)
Pertanto, appare condivisibile la considerazione secondo la quale, a fronte del-
l’inevitabile recessività del diritto alla privacy dinanzi “all’esigenza di giustizia ed
allo jus defendendi”, la riservatezza vada protetta non “attraverso limiti all’acqui-
sizione dei dati (…), bensì nel momento della conservazione degli stessi” .
(22)
2. Diritto alla privacy?
Com’è noto, la Carta del 1948 - non potendo i Padri costituenti prevedere un
simile sviluppo della tecnica, riconoscendone tuttavia la possibilità - nei suoi pur
generosi 139 articoli, non contempla espressamente la tutela della privatezza.
Pertanto, fin dai primi anni dell’era digitale, gli interpreti tentarono di giungere
ermeneuticamente alla ricomposizione della norma vigente con il divenire in muta-
mento, accompagnati dalla copiosa azione della giurisprudenza costituzionale e
sovranazionale, rinvenendo le basi di una tutela della privacy nel combinato disposto
di diversi articoli , segnatamente: l’art. 2 Cost., emblematicamente posto tra i
(23)
“principi fondamentali” in cui si afferma con forza che la Repubblica “riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”, diritti che - volendo considerare la norma
una valvola di sfogo, una “fattispecie aperta” - potrebbero agilmente consentire
(24)
di farvi rientrare implicite anche quello alla privatezza; l’art. 15 Cost., collocato in
una posizione privilegiata nell’ambito dei “rapporti civili” - primo titolo della parte
relativa ai “diritti e doveri dei cittadini” -, conferisce alla tutela della libertà e segre-
tezza delle comunicazioni una topologia di prim’ordine, subito in coda a libertà per-
sonale e inviolabilità del domicilio, fondamenta dei diritti dell’uomo moderno.
Treccani, (http://www.treccani.it/enciclopedia/privacy_%28Enciclopedia-delle-scienze-
sociali%29/), consultato il 5 agosto 2019, la definisce così: “nella comune accezione il con-
cetto di diritto alla privacy viene impiegato per indicare la tutela della riservatezza delle per-
sone, se le informazioni che le riguardano sono raccolte in banche dati in vista di un loro
impiego non personale. Sotto questo profilo si può ancora affermare che il diritto alla riser-
vatezza ha un contenuto parzialmente diverso: indica il diritto di impedire ad altri la cono-
scenza di ciò che la persona non desidera sia reso noto”.
(21) S. LORUSSO, L’arte di ascoltare e l’investigazione penale tra esigenze di giustizia e tutela della privatezza, cit.
(22) C. CONTI, Riforma Orlando: riprese fraudolente, intercettazioni, archiviazione e impugnazioni - le nuove
norme sulla riservatezza delle intercettazioni: anatomia di una riforma discussa, in GIUR. IT., 2018, 7,
pag. 1754 (commento alla normativa).
(23) Riprendendo la sistematica di S. LORUSSO, L’arte di ascoltare e l’investigazione penale tra esigenze di
giustizia e tutela della privatezza, cit.
(24) Ibidem, pag. 3.
59