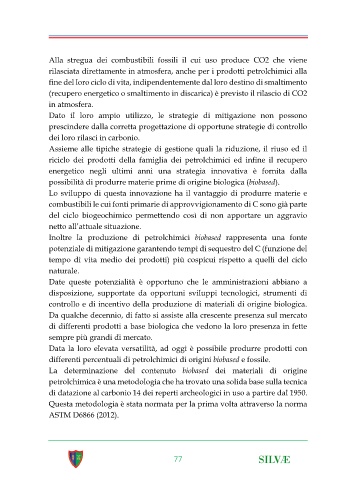Page 77 - Silvae MAggio Agosto
P. 77
Alla stregua dei combustibili fossili il cui uso produce CO2 che viene
rilasciata direttamente in atmosfera, anche per i prodotti petrolchimici alla
fine del loro ciclo di vita, indipendentemente dal loro destino di smaltimento
(recupero energetico o smaltimento in discarica) è previsto il rilascio di CO2
in atmosfera.
Dato il loro ampio utilizzo, le strategie di mitigazione non possono
prescindere dalla corretta progettazione di opportune strategie di controllo
dei loro rilasci in carbonio.
Assieme alle tipiche strategie di gestione quali la riduzione, il riuso ed il
riciclo dei prodotti della famiglia dei petrolchimici ed infine il recupero
energetico negli ultimi anni una strategia innovativa è fornita dalla
possibilità di produrre materie prime di origine biologica (biobased).
Lo sviluppo di questa innovazione ha il vantaggio di produrre materie e
combustibili le cui fonti primarie di approvvigionamento di C sono già parte
del ciclo biogeochimico permettendo così di non apportare un aggravio
netto all’attuale situazione.
Inoltre la produzione di petrolchimici biobased rappresenta una fonte
potenziale di mitigazione garantendo tempi di sequestro del C (funzione del
tempo di vita medio dei prodotti) più cospicui rispetto a quelli del ciclo
naturale.
Date queste potenzialità è opportuno che le amministrazioni abbiano a
disposizione, supportate da opportuni sviluppi tecnologici, strumenti di
controllo e di incentivo della produzione di materiali di origine biologica.
Da qualche decennio, di fatto si assiste alla crescente presenza sul mercato
di differenti prodotti a base biologica che vedono la loro presenza in fette
sempre più grandi di mercato.
Data la loro elevata versatilità, ad oggi è possibile produrre prodotti con
differenti percentuali di petrolchimici di origini biobased e fossile.
La determinazione del contenuto biobased dei materiali di origine
petrolchimica è una metodologia che ha trovato una solida base sulla tecnica
di datazione al carbonio 14 dei reperti archeologici in uso a partire dal 1950.
Questa metodologia è stata normata per la prima volta attraverso la norma
ASTM D6866 (2012).
77