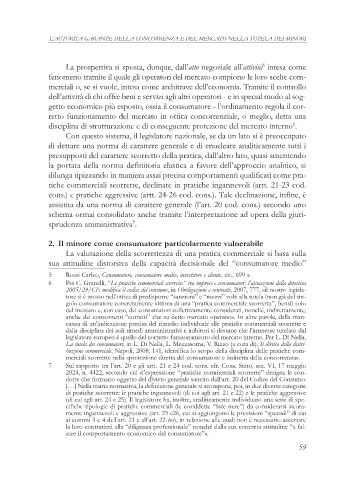Page 307 - Rassegna 2024-4_1
P. 307
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA TUTELA DEI MINORI
5
La prospettiva si sposta, dunque, dall’atto negoziale all’attività intesa come
fenomeno tramite il quale gli operatori del mercato compiono le loro scelte com-
merciali o, se si vuole, intesa come architrave dell’economia. Tramite il controllo
dell’attività di chi offre beni e servizi agli altri operatori - e in special modo al sog-
getto economico più esposto, ossia il consumatore - l’ordinamento regola il cor-
retto funzionamento del mercato in ottica concorrenziale, o meglio, detta una
disciplina di strutturazione e di conseguente protezione del mercato interno .
6
Con questo sistema, il legislatore nazionale, se da un lato si è preoccupato
di dettare una norma di carattere generale e di enucleare analiticamente tutti i
presupposti del carattere scorretto della pratica, dall’altro lato, quasi smentendo
la portata della norma definitoria elastica a favore dell’approccio analitico, si
dilunga tipizzando in maniera assai precisa comportamenti qualificati come pra-
tiche commerciali scorrette, declinate in pratiche ingannevoli (artt. 21-23 cod.
cons.) e pratiche aggressive (artt. 24-26 cod. cons.). Tale declinazione, infine, è
assistita da una norma di carattere generale (l’art. 20 cod. cons.) secondo uno
schema ormai consolidato anche tramite l’interpretazione ad opera della giuri-
sprudenza amministrativa .
7
2. Il minore come consumatore particolarmente vulnerabile
La valutazione della scorrettezza di una pratica commerciale si basa sulla
sua attitudine distorsiva della capacità decisionale del “consumatore medio”
5 Rossi Carleo, Consumatore, consumatore medio, investitore e cliente, cit., 699 s.
6 Per C. Granelli, “Le pratiche commerciali scorrette” tra imprese e consumatori: l’attuazione della direttiva
2005/29/CE modifica il codice del consumo, in Obbligazioni e contratti, 2007, 777, «il nostro legisla-
tore si è mosso nell’ottica di predisporre “sanzioni” e “mezzi” volti alla tutela (non già del sin-
golo consumatore concretamente vittima di una “pratica commerciale scorretta”, bensì) solo
del mercato e, con esso, dei consumatori collettivamente considerati, nonché, indirettamente,
anche dei concorrenti “corretti” che su detto mercato operano». In altre parole, dalla man-
canza di un’indicazione precisa del rimedio individuale alle pratiche commerciali scorrette e
dalla disciplina dei soli rimedi amministrativi e inibitori si desume che l’interesse tutelato dal
legislatore europeo è quello del corretto funzionamento del mercato interno. Per L. Di Nella,
La tutela dei consumatori, in L. Di Nella, L. Mezzasoma, V. Rizzo (a cura di), Il diritto della distri-
buzione commerciale, Napoli, 2008, 141, identifica lo scopo della disciplina delle pratiche com-
merciali scorrette nella «protezione diretta del consumatore e indiretta della concorrenza».
7 Sul rapporto tra l’art. 20 e gli artt. 21 e 24 cod. cons. cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 maggio
2024, n. 4422, secondo cui «l’espressione “pratiche commerciali scorrette” designa le con-
dotte che formano oggetto del divieto generale sancito dall’art. 20 del Codice del Consumo.
[…] Nella trama normativa, la definizione generale si scompone, poi, in due diverse categorie
di pratiche scorrette: le pratiche ingannevoli (di cui agli art. 21 e 22) e le pratiche aggressive
(di cui agli art. 24 e 25). Il legislatore ha, inoltre, analiticamente individuato una serie di spe-
cifiche tipologie di pratiche commerciali (le cosiddette “liste nere”) da considerarsi sicura-
mente ingannevoli e aggressive (art. 23 e26, cui si aggiungono le previsioni “speciali” di cui
ai commi 3 e 4 dell’art. 21 e all’art. 22-bis), in relazione alle quali non è necessario accertare
la loro contrarietà alla “diligenza professionale” nonché dalla sua concreta attitudine “a fal-
sare il comportamento economico del consumatore”».
59