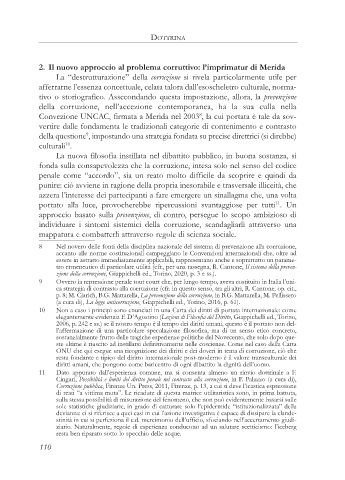Page 112 - Rassegna 2024-4_1
P. 112
DOTTRINA
2. Il nuovo approccio al problema corruttivo: l’imprimatur di Merida
La “destrutturazione” della corruzione si rivela particolarmente utile per
afferrarne l’essenza concettuale, celata talora dall’esoscheletro culturale, norma-
tivo o storiografico. Assecondando questa impostazione, allora, la prevenzione
della corruzione, nell’accezione contemporanea, ha la sua culla nella
8
Convezione UNCAC, firmata a Merida nel 2003 , la cui portata è tale da sov-
vertire dalle fondamenta le tradizionali categorie di contenimento e contrasto
9
della questione , impostando una strategia fondata su precise direttrici (si direbbe)
10
culturali .
La nuova filosofia instillata nel dibattito pubblico, in buona sostanza, si
fonda sulla consapevolezza che la corruzione, intesa solo nel senso del codice
penale come “accordo”, sia un reato molto difficile da scoprire e quindi da
punire: ciò avviene in ragione della propria inesorabile e trasversale illiceità, che
azzera l’interesse dei partecipanti a fare emergere un sinallagma che, una volta
portato alla luce, provocherebbe ripercussioni svantaggiose per tutti . Un
11
approccio basato sulla prevenzione, di contro, persegue lo scopo ambizioso di
individuare i sintomi sistemici della corruzione, scandagliarli attraverso una
mappatura e combatterli attraverso regole di scienza sociale.
8 Nel novero delle fonti della disciplina nazionale del sistema di prevenzione alla corruzione,
accanto alle norme costituzionali campeggiano le Convenzioni internazionali che, oltre ad
essere in astratto immediatamente applicabili, rappresentano anche e soprattutto un parame-
tro ermeneutico di particolare utilità (cfr., per una rassegna, R. Cantone, Il sistema della preven-
zione della corruzione, Giappichelli ed., Torino, 2020, p. 3 e ss.).
9 Ovvero la repressione penale tout court che, per lungo tempo, aveva costituito in Italia l’uni-
ca strategia di contrasto alla corruzione (cfr. in questo senso, tra gli altri, R. Cantone, op. cit.,
p. 8; M. Clarich, B.G. Mattarella, La prevenzione della corruzione, in B.G. Mattarella, M. Pellissero
(a cura di), La legge anticorruzione, Giappichelli ed., Torino, 2016, p. 61).
10 Non a caso i principi sono enunciati in una Carta dei diritti di portata internazionale: come
elegantemente evidenzia F. D’Agostino (Lezioni di Filosofia del Diritto, Giappichelli ed., Torino,
2006, p. 242 e ss.) se il nostro tempo è il tempo dei diritti umani, questo è il portato non del-
l’affermazione di una particolare speculazione filosofica, ma di un senso etico concreto,
sostanzialmente frutto delle tragiche esperienze politiche del Novecento, che solo dopo que-
ste ultime è riuscito ad instillarsi definitivamente nelle coscienze. Come nel caso della Carta
ONU che qui esegue una ricognizione dei diritti e dei doveri in tema di corruzione, ciò che
resta fondante e tipico del diritto internazionale post-moderno è il valore transculturale dei
diritti umani, che pongono come baricentro di ogni dibattito la dignità dell’uomo.
11 Dato appurato dall’esperienza comune, ma si consenta almeno un rinvio dottrinale a F.
Cingari, Possibilità e limiti del diritto penale nel contrasto alla corruzione, in F. Palazzo (a cura di),
Corruzione pubblica, Firenze Un. Press, 2011, Firenze, p. 13, a cui si deve l’icastica espressione
di reati “a vittima muta”. Le ricadute di questa matrice utilitaristica sono, in prima battuta,
sulla stessa possibilità di misurazione del fenomeno, che non può evidentemente basarsi sulle
sole statistiche giudiziarie, in grado di catturare solo l’epidermide “istituzionalizzata” della
devianza: ci si riferisce a quei casi in cui l’azione investigativa è capace di dissipare la clande-
stinità in cui si perfeziona il c.d. mercimonio dell’ufficio, sfociando nell’accertamento giudi-
ziario. Naturalmente, regole di esperienza conducono ad un salutare scetticismo: l’iceberg
resta ben riparato sotto lo specchio delle acque.
110