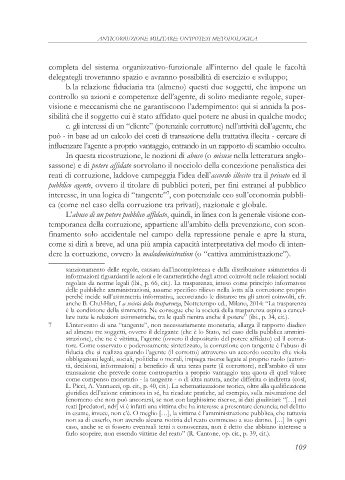Page 111 - Rassegna 2024-4_1
P. 111
ANTICORRUZIONE MILITARE: UN’IPOTESI METODOLOGICA
completa del sistema organizzativo-funzionale all’interno del quale le facoltà
delegategli troveranno spazio e avranno possibilità di esercizio e sviluppo;
b. la relazione fiduciaria tra (almeno) questi due soggetti, che impone un
controllo su azioni e competenze dell’agente, di solito mediante regole, super-
visione e meccanismi che ne garantiscono l’adempimento: qui si annida la pos-
sibilità che il soggetto cui è stato affidato quel potere ne abusi in qualche modo;
c. gli interessi di un “cliente” (potenziale corruttore) nell’attività dell’agente, che
può - in base ad un calcolo dei costi di transazione della trattativa illecita - cercare di
influenzare l’agente a proprio vantaggio, entrando in un rapporto di scambio occulto.
In questa ricostruzione, le nozioni di abuso (o misuse nella letteratura anglo-
sassone) e di potere affidato sorvolano il nocciolo della concezione penalistica dei
reati di corruzione, laddove campeggia l’idea dell’accordo illecito tra il privato ed il
pubblico agente, ovvero il titolare di pubblici poteri, per fini estranei al pubblico
interesse, in una logica di “tangente” , con potenziale eco sull’economia pubbli-
7
ca (come nel caso della corruzione tra privati), nazionale e globale.
L’abuso di un potere pubblico affidato, quindi, in linea con la generale visione con-
temporanea della corruzione, appartiene all’ambito della prevenzione, con scon-
finamento solo accidentale nel campo della repressione penale e apre la stura,
come si dirà a breve, ad una più ampia capacità interpretativa del modo di inten-
dere la corruzione, ovvero la maladministration (o “cattiva amministrazione”).
sanzionamento delle regole, causata dall’incompletezza e dalla distribuzione asimmetrica di
informazioni riguardanti le azioni e le caratteristiche degli attori coinvolti nelle relazioni sociali
regolate da norme legali (ibi., p. 66, cit.). La trasparenza, inteso come principio informatore
delle pubbliche amministrazioni, assume specifico rilievo nella lotta alla corruzione proprio
perché incide sull’asimmetria informativa, accorciando le distanze tra gli attori coinvolti, cfr.
anche B. Chul-Han, La società della trasparenza, Nottetempo ed., Milano, 2014: “La trasparenza
è la condizione della simmetria. Ne consegue che la società della trasparenza aspira a cancel-
lare tutte le relazioni asimmetriche, tra le quali rientra anche il potere” (ibi., p. 34, cit.).
7 L’intervento di una “tangente”, non necessariamente monetaria, allarga il rapporto diadico
ad almeno tre soggetti, ovvero il delegante (che è lo Stato, nel caso della pubblica ammini-
strazione), che ne è vittima, l’agente (ovvero il depositario del potere affidato) ed il corrut-
tore. Come osservato e poderosamente sintetizzato, la corruzione con tangente è l’abuso di
fiducia che si realizza quando l’agente (il corrotto) attraverso un accordo occulto che viola
obbligazioni legali, sociali, politiche o morali, impiega risorse legate al proprio ruolo (autori-
tà, decisioni, informazioni) a beneficio di una terza parte (il corruttore), nell’ambito di una
transazione che prevede come contropartita a proprio vantaggio una quota di quel valore
come compenso monetario - la tangente - o di altra natura, anche differita o indiretta (così,
L. Picci, A. Vannucci, op. cit., p. 40, cit.). La schematizzazione teorica, oltre alla qualificazione
giuridica dell’azione criminosa in sé, ha ricadute pratiche, ad esempio, sulla misurazione del
fenomeno che non può ancorarsi, se non con larghissime riserve, ai dati giudiziari: “[…] nei
reati [predatori, ndr] vi è infatti una vittima che ha interesse a presentare denuncia; nel delitto
in esame, invece, non c’è. O meglio […], la vittima è l’amministrazione pubblica, che tuttavia
non sa di esserlo, non avendo alcuna notizia del reato commesso a suo danno. […] In ogni
caso, anche se ci fossero eventuali terzi a conoscenza, non è detto che abbiano interesse a
farlo scoprire, non essendo vittime del reato” (R. Cantone, op. cit., p. 39, cit.).
109