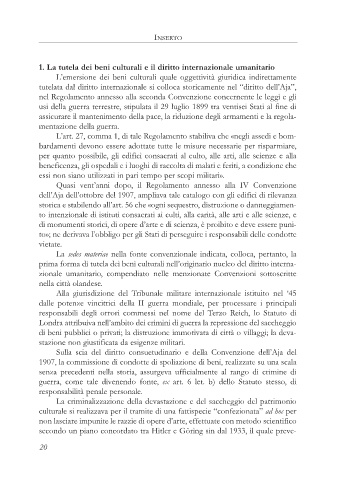Page 22 - Rassegna 2024-2_Inserto
P. 22
INSERTO
1. La tutela dei beni culturali e il diritto internazionale umanitario
L’emersione dei beni culturali quale oggettività giuridica indirettamente
tutelata dal diritto internazionale si colloca storicamente nel “diritto dell’Aja”,
nel Regolamento annesso alla seconda Convenzione concernente le leggi e gli
usi della guerra terrestre, stipulata il 29 luglio 1899 tra ventisei Stati al fine di
assicurare il mantenimento della pace, la riduzione degli armamenti e la regola-
mentazione della guerra.
L’art. 27, comma 1, di tale Regolamento stabiliva che «negli assedi e bom-
bardamenti devono essere adottate tutte le misure necessarie per risparmiare,
per quanto possibile, gli edifici consacrati al culto, alle arti, alle scienze e alla
beneficenza, gli ospedali e i luoghi di raccolta di malati e feriti, a condizione che
essi non siano utilizzati in pari tempo per scopi militari».
Quasi vent’anni dopo, il Regolamento annesso alla IV Convenzione
dell’Aja dell’ottobre del 1907, ampliava tale catalogo con gli edifici di rilevanza
storica e stabilendo all’art. 56 che «ogni sequestro, distruzione o danneggiamen-
to intenzionale di istituti consacrati ai culti, alla carità, alle arti e alle scienze, e
di monumenti storici, di opere d’arte e di scienza, è proibito e deve essere puni-
to»; ne derivava l’obbligo per gli Stati di perseguire i responsabili delle condotte
vietate.
La sedes materiae nella fonte convenzionale indicata, colloca, pertanto, la
prima forma di tutela dei beni culturali nell’originario nucleo del diritto interna-
zionale umanitario, compendiato nelle menzionate Convenzioni sottoscritte
nella città olandese.
Alla giurisdizione del Tribunale militare internazionale istituito nel ‘45
dalle potenze vincitrici della II guerra mondiale, per processare i principali
responsabili degli orrori commessi nel nome del Terzo Reich, lo Statuto di
Londra attribuiva nell’ambito dei crimini di guerra la repressione del saccheggio
di beni pubblici o privati; la distruzione immotivata di città o villaggi; la deva-
stazione non giustificata da esigenze militari.
Sulla scia del diritto consuetudinario e della Convenzione dell’Aja del
1907, la commissione di condotte di spoliazione di beni, realizzate su una scala
senza precedenti nella storia, assurgeva ufficialmente al rango di crimine di
guerra, come tale divenendo fonte, ex art. 6 let. b) dello Statuto stesso, di
responsabilità penale personale.
La criminalizzazione della devastazione e del saccheggio del patrimonio
culturale si realizzava per il tramite di una fattispecie “confezionata” ad hoc per
non lasciare impunite le razzie di opere d’arte, effettuate con metodo scientifico
secondo un piano concordato tra Hitler e Göring sin dal 1933, il quale preve-
20