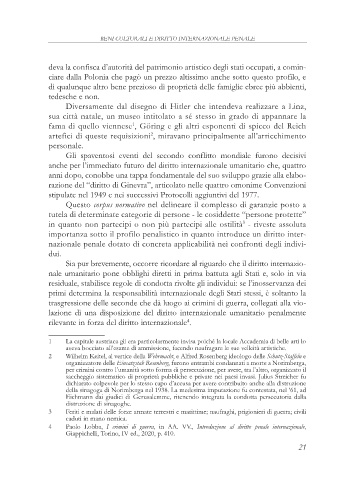Page 23 - Rassegna 2024-2_Inserto
P. 23
BENI CULTURALI E DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE
deva la confisca d’autorità del patrimonio artistico degli stati occupati, a comin-
ciare dalla Polonia che pagò un prezzo altissimo anche sotto questo profilo, e
di qualunque altro bene prezioso di proprietà delle famiglie ebree più abbienti,
tedesche e non.
Diversamente dal disegno di Hitler che intendeva realizzare a Linz,
sua città natale, un museo intitolato a sé stesso in grado di appannare la
1
fama di quello viennese , Göring e gli altri esponenti di spicco del Reich
artefici di queste requisizioni , miravano principalmente all’arricchimento
2
personale.
Gli spaventosi eventi del secondo conflitto mondiale furono decisivi
anche per l’immediato futuro del diritto internazionale umanitario che, quattro
anni dopo, conobbe una tappa fondamentale del suo sviluppo grazie alla elabo-
razione del “diritto di Ginevra”, articolato nelle quattro omonime Convenzioni
stipulate nel 1949 e nei successivi Protocolli aggiuntivi del 1977.
Questo corpus normativo nel delineare il complesso di garanzie posto a
tutela di determinate categorie di persone - le cosiddette “persone protette”
3
in quanto non partecipi o non più partecipi alle ostilità - riveste assoluta
importanza sotto il profilo penalistico in quanto introduce un diritto inter-
nazionale penale dotato di concreta applicabilità nei confronti degli indivi-
dui.
Sia pur brevemente, occorre ricordare al riguardo che il diritto internazio-
nale umanitario pone obblighi diretti in prima battuta agli Stati e, solo in via
residuale, stabilisce regole di condotta rivolte gli individui: se l’inosservanza dei
primi determina la responsabilità internazionale degli Stati stessi, è soltanto la
trasgressione delle seconde che dà luogo ai crimini di guerra, collegati alla vio-
lazione di una disposizione del diritto internazionale umanitario penalmente
rilevante in forza del diritto internazionale .
4
1 La capitale austriaca gli era particolarmente invisa poiché la locale Accademia di belle arti lo
aveva bocciato all’esame di ammissione, facendo naufragare le sue velleità artistiche.
2 Wilhelm Keitel, al vertice della Wehrmacht, e Alfred Rosenberg ideologo delle Schutz-Staffeln e
organizzatore delle Einsatzstab Rosenberg, furono entrambi condannati a morte a Norimberga,
per crimini contro l’umanità sotto forma di persecuzione, per avere, tra l’altro, organizzato il
saccheggio sistematico di proprietà pubbliche e private nei paesi invasi. Julius Streicher fu
dichiarato colpevole per lo stesso capo d’accusa per avere contribuito anche alla distruzione
della sinagoga di Norimberga nel 1938. La medesima imputazione fu contestata, nel ’61, ad
Eichmann dai giudici di Gerusalemme, ritenendo integrata la condotta persecutoria dalla
distruzione di sinagoghe.
3 Feriti e malati delle forze armate terrestri e marittime; naufraghi, prigionieri di guerra; civili
caduti in mano nemica.
4 Paolo Lobba, I crimini di guerra, in AA. VV., Introduzione al diritto penale internazionale,
Giappichelli, Torino, IV ed., 2020, p. 410.
21