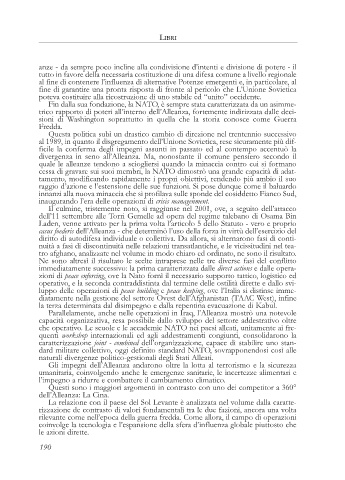Page 192 - Rassegna 2024-1
P. 192
LIBRI
anze - da sempre poco incline alla condivisione d’intenti e divisione di potere - il
tutto in favore della necessaria costituzione di una difesa comune a livello regionale
al fine di contenere l’influenza di alternative Potenze emergenti e, in particolare, al
fine di garantire una pronta risposta di fronte al pericolo che L’Unione Sovietica
poteva costituire alla ricostruzione di uno stabile ed “unito” occidente.
Fin dalla sua fondazione, la NATO, è sempre stata caratterizzata da un asimme-
trico rapporto di poteri all’interno dell’Alleanza, fortemente indirizzata dalle deci-
sioni di Washington soprattutto in quella che la storia conosce come Guerra
Fredda.
Questa politica subì un drastico cambio di direzione nel trentennio successivo
al 1989, in quanto il disgregamento dell’Unione Sovietica, rese sicuramente più dif-
ficile la conferma degli impegni assunti in passato ed al contempo accentuò la
divergenza in seno all’Alleanza. Ma, nonostante il comune pensiero secondo il
quale le alleanze tendono a sciogliersi quando la minaccia contro cui si formano
cessa di gravare sui suoi membri, la NATO dimostrò una grande capacità di adat-
tamento, modificando rapidamente i propri obiettivi, rendendo più ambio il suo
raggio d’azione e l’estensione delle sue funzioni. Si pose dunque come il baluardo
innanzi alla nuova minaccia che si profilava sulle sponde del cosiddetto Fianco Sud,
inaugurando l’era delle operazioni di crisis managenment.
Il culmine, tristemente noto, si raggiunse nel 2001, ove, a seguito dell’attacco
dell’11 settembre alle Torri Gemelle ad opera del regime talebano di Osama Bin
Laden, venne attivato per la prima volta l’articolo 5 dello Statuto - vero e proprio
casus foederis dell’Alleanza - che determinò l’uso della forza in virtù dell’esercizio del
diritto di autodifesa individuale o collettiva. Da allora, si alternarono fasi di conti-
nuità a fasi di discontinuità nelle relazioni transatlantiche, e le vicissitudini nel tea-
tro afghano, analizzate nel volume in modo chiaro ed ordinato, ne sono il risultato.
Ne sono altresì il risultato le scelte intraprese nelle tre diverse fasi del conflitto
immediatamente successivo: la prima caratterizzata dalle direct actions e dalle opera-
zioni di peace enforcing, ove la Nato fornì il necessario supporto tattico, logistico ed
operativo, e la seconda contraddistinta dal termine delle ostilità dirette e dallo svi-
luppo delle operazioni di peace building e peace keeping, ove l’Italia si distinse imme-
diatamente nella gestione del settore Ovest dell’Afghanistan (TAAC West), infine
la terza determinata dal disimpegno e dalla repentina evacuazione di Kabul.
Parallelamente, anche nelle operazioni in Iraq, l’Alleanza mostrò una notevole
capacità organizzativa, resa possibile dallo sviluppo del settore addestrativo oltre
che operativo. Le scuole e le accademie NATO nei paesi alleati, unitamente ai fre-
quenti workshop internazionali ed agli addestramenti congiunti, consolidarono la
caratterizzazione joint - combined dell’organizzazione, capace di stabilire uno stan-
dard militare collettivo, oggi definito standard NATO, sovrapponendosi così alle
naturali divergenze politico-gestionali degli Stati Alleati.
Gli impegni dell’Alleanza andarono oltre la lotta al terrorismo e la sicurezza
umanitaria, coinvolgendo anche le emergenze sanitarie, le incertezze alimentari e
l’impegno a ridurre e combattere il cambiamento climatico.
Questi sono i maggiori argomenti in contrasto con uno dei competitor a 360°
dell’Alleanza: La Cina.
La relazione con il paese del Sol Levante è analizzata nel volume dalla caratte-
rizzazione de contrasto di valori fondamentali tra le due fazioni, ancora una volta
rilevante come nell’epoca della guerra fredda. Come allora, il campo di operazioni
coinvolge la tecnologia e l’espansione della sfera d’influenza globale piuttosto che
le azioni dirette.
190