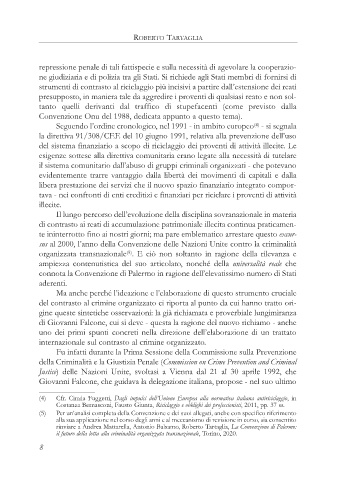Page 10 - Rassegna 2023-4_Inserto
P. 10
ROBERTO TARTAGLIA
repressione penale di tali fattispecie e sulla necessità di agevolare la cooperazio-
ne giudiziaria e di polizia tra gli Stati. Si richiede agli Stati membri di fornirsi di
strumenti di contrasto al riciclaggio più incisivi a partire dall’estensione dei reati
presupposto, in maniera tale da aggredire i proventi di qualsiasi reato e non sol-
tanto quelli derivanti dal traffico di stupefacenti (come previsto dalla
Convenzione Onu del 1988, dedicata appunto a questo tema).
Seguendo l’ordine cronologico, nel 1991 - in ambito europeo - si segnala
(4)
la direttiva 91/308/CEE del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell’uso
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Le
esigenze sottese alla direttiva comunitaria erano legate alla necessità di tutelare
il sistema comunitario dall’abuso di gruppi criminali organizzati - che potevano
evidentemente trarre vantaggio dalla libertà dei movimenti di capitali e dalla
libera prestazione dei servizi che il nuovo spazio finanziario integrato compor-
tava - nei confronti di enti creditizi e finanziari per riciclare i proventi di attività
illecite.
Il lungo percorso dell’evoluzione della disciplina sovranazionale in materia
di contrasto ai reati di accumulazione patrimoniale illecita continua praticamen-
te ininterrotto fino ai nostri giorni; ma pare emblematico arrestare questo excur-
sus al 2000, l’anno della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità
organizzata transnazionale . E ciò non soltanto in ragione della rilevanza e
(5)
ampiezza contenutistica del suo articolato, nonché della universalità reale che
connota la Convenzione di Palermo in ragione dell’elevatissimo numero di Stati
aderenti.
Ma anche perché l’ideazione e l’elaborazione di questo strumento cruciale
del contrasto al crimine organizzato ci riporta al punto da cui hanno tratto ori-
gine queste sintetiche osservazioni: la già richiamata e proverbiale lungimiranza
di Giovanni Falcone, cui si deve - questa la ragione del nuovo richiamo - anche
uno dei primi spunti concreti nella direzione dell’elaborazione di un trattato
internazionale sul contrasto al crimine organizzato.
Fu infatti durante la Prima Sessione della Commissione sulla Prevenzione
della Criminalità e la Giustizia Penale (Commission on Crime Prevention and Criminal
Justice) delle Nazioni Unite, svoltasi a Vienna dal 21 al 30 aprile 1992, che
Giovanni Falcone, che guidava la delegazione italiana, propose - nel suo ultimo
(4) Cfr. Cinzia Fuggetti, Dagli impulsi dell’Unione Europea alla normativa italiana antiriciclaggio, in
Costanza Bernasconi, Fausto Giunta, Riciclaggio e obblighi dei professionisti, 2011, pp. 37 ss.
(5) Per un’analisi completa della Convenzione e dei suoi allegati, anche con specifico riferimento
alla sua applicazione nel corso degli anni e al meccanismo di revisione in corso, sia consentito
rinviare a Andrea Mattarella, Antonio Balsamo, Roberto Tartaglia, La Convenzione di Palermo:
il futuro della lotta alla criminalità organizzata transnazionale, Torino, 2020.
8