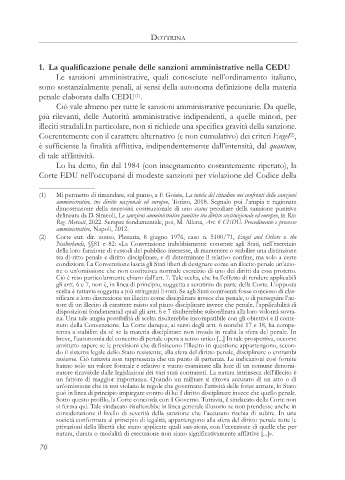Page 72 - Rassegna 2023-3
P. 72
DOTTRINA
1. La qualificazione penale delle sanzioni amministrative nella CEDU
Le sanzioni amministrative, quali conosciute nell’ordinamento italiano,
sono sostanzialmente penali, ai sensi della autonoma definizione della materia
penale elaborata dalla CEDU .
(1)
Ciò vale almeno per tutte le sanzioni amministrative pecuniarie. Da quelle,
più rilevanti, delle Autorità amministrative indipendenti, a quelle minori, per
illeciti stradali.In particolare, non si richiede una specifica gravità della sanzione.
Coerentemente con il carattere alternativo (e non cumulativo) dei criteri Engel ,
(2)
è sufficiente la finalità afflittiva, indipendentemente dall’intensità, dal quantum,
di tale afflittività.
Lo ha detto, fin dal 1984 (con insegnamento costantemente ripetuto), la
Corte EDU nell’occuparsi di modeste sanzioni per violazione del Codice della
(1) Mi permetto di rimandare, sul punto, a F. Goisis, La tutela del cittadino nei confronti delle sanzioni
amministrative, tra diritto nazionale ed europeo, Torino, 2018. Segnalo poi l’ampia e ragionata
dimostrazione della necessità costituzionale di uno status peculiare della sanzione punitiva
delineata da D. Simeoli, Le sanzioni amministrative punitive tra diritto costituzionale ed europeo, in Riv.
Reg. Mercati, 2022. Sempre fondamentale, poi, M. Allena, Art. 6 CEDU. Procedimento e processo
amministrativo, Napoli, 2012.
(2) Corte eur. dir. uomo, Plenaria, 8 giugno 1976, caso n. 5100/71, Engel and Others v. the
Netherlands, §§81 e 82: «La Convenzione indubbiamente consente agli Stati, nell’esercizio
della loro funzione di custodi del pubblico interesse, di mantenere o stabilire una distinzione
tra di-ritto penale e diritto disciplinare, e di determinare il relativo confine, ma solo a certe
condizioni. La Convenzione lascia gli Stati liberi di designare come un illecito penale un’azio-
ne o un’omissione che non costituisca normale esercizio di uno dei diritti da essa protetto.
Ciò è reso particolarmente chiaro dall’art. 7. Tale scelta, che ha l’effetto di rendere applicabili
gli artt. 6 e 7, non è, in linea di principio, soggetta a scrutinio da parte della Corte. L’opposta
scelta è tuttavia soggetta a più stringenti li-miti. Se agli Stati contraenti fosse concesso di clas-
sificare a loro discrezione un illecito come disciplinare invece che penale, o di perseguire l’au-
tore di un illecito di carattere misto sul piano disciplinare invece che penale, l’applicabilità di
disposizioni fondamentali quali gli artt. 6 e 7 risulterebbe subordinata alla loro volontà sovra-
na. Una tale ampia possibilità di scelta risulterebbe incompatibile con gli obiettivi e il conte-
nuto della Convenzione. La Corte dunque, ai sensi degli artt. 6 nonché 17 e 18, ha compe-
tenza a stabilire da sé se la materia disciplinare non invada in realtà la sfera del penale. In
breve, l’autonomia del concetto di penale opera a senso unico [...] In tale prospettiva, occorre
anzitutto sapere se le previsioni che definiscono l’illecito in questione appartengono, secon-
do il sistema legale dello Stato resistente, alla sfera del diritto penale, disciplinare o entrambi
assieme. Ciò tuttavia non rappresenta che un punto di partenza. Le indicazioni così fornite
hanno solo un valore formale e relativo e vanno esaminate alla luce di un comune denomi-
natore ricavabile dalle legislazioni dei vari stati contraenti. La natura intrinseca dell’illecito è
un fattore di maggior importanza. Quando un militare si ritrova accusato di un atto o di
un’omissione che in tesi violano le regole che governano l’attività delle forze armate, lo Stato
può in linea di principio impiegare contro di lui il diritto disciplinare invece che quello penale.
Sotto questo profilo, la Corte concorda con il Governo. Tuttavia, il sindacato della Corte non
si ferma qui. Tale sindacato risulterebbe in linea generale illusorio se non prendesse anche in
considerazione il livello di severità della sanzione che l’accusato rischia di subire. In una
società conformata al principio di legalità, appartengono alla sfera del diritto penale tutte le
privazioni della libertà che siano applicate quali san-zioni, con l’eccezione di quelle che per
natura, durata o modalità di esecuzione non siano significativamente afflittive [...]».
70