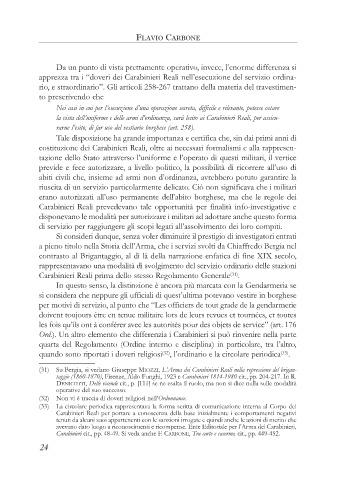Page 26 - Rassegna 2022-4_Inserto
P. 26
FLAVIO CARBONE
Da un punto di vista prettamente operativo, invece, l’enorme differenza si
apprezza tra i “doveri dei Carabinieri Reali nell’esecuzione del servizio ordina-
rio, e straordinario”. Gli articoli 258-267 trattano della materia del travestimen-
to prescrivendo che
Nei casi in cui per l’esecuzione d’una operazione secreta, difficile e rilevante, potesse ostare
la vista dell’uniforme e delle armi d’ordinanza, sarà lecito ai Carabinieri Reali, per assicu-
rarne l’esito, di far uso del vestiario borghese (art. 258).
Tale disposizione ha grande importanza e certifica che, sin dai primi anni di
costituzione dei Carabinieri Reali, oltre ai necessari formalismi e alla rappresen-
tazione dello Stato attraverso l’uniforme e l’operato di questi militari, il vertice
previde e fece autorizzare, a livello politico, la possibilità di ricorrere all’uso di
abiti civili che, insieme ad armi non d’ordinanza, avrebbero potuto garantire la
riuscita di un servizio particolarmente delicato. Ciò non significava che i militari
erano autorizzati all’uso permanente dell’abito borghese, ma che le regole dei
Carabinieri Reali prevedevano tale opportunità per finalità info-investigative e
disponevano le modalità per autorizzare i militari ad adottare anche questo forma
di servizio per raggiungere gli scopi legati all’assolvimento dei loro compiti.
Si consideri dunque, senza voler diminuire il prestigio di investigatori entrati
a pieno titolo nella Storia dell’Arma, che i servizi svolti da Chiaffredo Bergia nel
contrasto al Brigantaggio, al di là della narrazione enfatica di fine XIX secolo,
rappresentavano una modalità di svolgimento del servizio ordinario delle stazioni
Carabinieri Reali prima dello stesso Regolamento Generale .
(31)
In questo senso, la distinzione è ancora più marcata con la Gendarmeria se
si considera che neppure gli ufficiali di quest’ultima potevano vestire in borghese
per motivi di servizio, al punto che “Les officiers de tout grade de la gendarmerie
doivent toujours être en tenue militaire lors de leurs revues et tournées, et toutes
les fois qu’ils ont à conférer avec les autorités pour des objets de service” (art. 176
Ord.). Un altro elemento che differenzia i Carabinieri si può rinvenire nella parte
quarta del Regolamento (Ordine interno e disciplina) in particolare, tra l’altro,
quando sono riportati i doveri religiosi , l’ordinario e la circolare periodica .
(32)
(33)
(31) Su Bergia, si vedano Giuseppe MIOZZI, L’Arma dei Carabinieri Reali nella repressione del brigan-
taggio (1860-1870), Firenze, Aldo Funghi, 1923 e Carabinieri 1814-1980 cit., pp. 204-217. In R.
DENICOTTI, Delle vicende cit., p. [111] se ne esalta il ruolo, ma non si dice nulla sulle modalità
operative del suo successo.
(32) Non vi è traccia di doveri religiosi nell’Ordonnance.
(33) La circolare periodica rappresentava la forma scritta di comunicazione interna al Corpo dei
Carabinieri Reali per portare a conoscenza della base inizialmente i comportamenti negativi
tenuti da alcuni suoi appartenenti con le sanzioni irrogate e quindi anche le azioni di merito che
avevano dato luogo a riconoscimenti e ricompense. Ente Editoriale per l’Arma dei Carabinieri,
Carabinieri cit., pp. 48-49. Si veda anche F. CARBONE, Tra carte e caserme, cit., pp. 449-452.
24