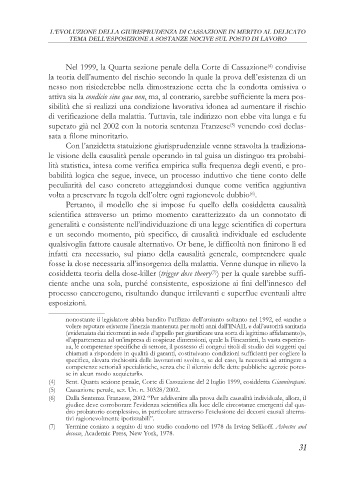Page 33 - Rassegna 2022-3
P. 33
L’EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DI CASSAZIONE IN MERITO AL DELICATO
TEMA DELL’ESPOSIZIONE A SOSTANZE NOCIVE SUL POSTO DI LAVORO
Nel 1999, la Quarta sezione penale della Corte di Cassazione condivise
(4)
la teoria dell’aumento del rischio secondo la quale la prova dell’esistenza di un
nesso non risiederebbe nella dimostrazione certa che la condotta omissiva o
attiva sia la condicio sine qua non, ma, al contrario, sarebbe sufficiente la mera pos-
sibilità che si realizzi una condizione lavorativa idonea ad aumentare il rischio
di verificazione della malattia. Tuttavia, tale indirizzo non ebbe vita lunga e fu
superato già nel 2002 con la notoria sentenza Franzese venendo così declas-
(5)
sata a filone minoritario.
Con l’anzidetta statuizione giurisprudenziale venne stravolta la tradiziona-
le visione della causalità penale operando in tal guisa un distinguo tra probabi-
lità statistica, intesa come verifica empirica sulla frequenza degli eventi, e pro-
babilità logica che segue, invece, un processo induttivo che tiene conto delle
peculiarità del caso concreto atteggiandosi dunque come verifica aggiuntiva
volta a preservare la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio .
(6)
Pertanto, il modello che si impose fu quello della cosiddetta causalità
scientifica attraverso un primo momento caratterizzato da un connotato di
generalità e consistente nell’individuazione di una legge scientifica di copertura
e un secondo momento, più specifico, di causalità individuale ed escludente
qualsivoglia fattore causale alternativo. Or bene, le difficoltà non finirono lì ed
infatti era necessario, sul piano della causalità generale, comprendere quale
fosse la dose necessaria all’insorgenza della malattia. Venne dunque in rilievo la
cosiddetta teoria della dose-killer (trigger dose theory ) per la quale sarebbe suffi-
(7)
ciente anche una sola, purché consistente, esposizione ai fini dell’innesco del
processo cancerogeno, risultando dunque irrilevanti e superflue eventuali altre
esposizioni.
nonostante il legislatore abbia bandito l’utilizzo dell’amianto soltanto nel 1992, ed «anche a
volere reputare esistente l’inerzia mantenuta per molti anni dall’INAIL e dall’autorità sanitaria
(evidenziata dai ricorrenti in sede d’appello per giustificare una sorta di legittimo affidamento)»,
«l’appartenenza ad un’impresa di cospicue dimensioni, quale la Fincantieri, la vasta esperien-
za, le competenze specifiche di settore, il possesso di congrui titoli di studio dei soggetti qui
chiamati a rispondere in qualità di garanti, costituivano condizioni sufficienti per cogliere la
specifica, elevata rischiosità delle lavorazioni svolte e, se del caso, la necessità ad attingere a
competenze settoriali specialistiche, senza che il silenzio delle dette pubbliche agenzie potes-
se in alcun modo acquietarli».
(4) Sent. Quarta sezione penale, Corte di Cassazione del 2 luglio 1999, cosiddetta Giannitrapani.
(5) Cassazione penale, sez. Un. n. 30328/2002.
(6) Dalla Sentenza Franzese, 2002 “Per addivenire alla prova della causalità individuale, allora, il
giudice deve corroborare l’evidenza scientifica alla luce delle circostanze emergenti dal qua-
dro probatorio complessivo, in particolare attraverso l’esclusione dei decorsi causali alterna-
tivi ragionevolmente ipotizzabili”.
(7) Termine coniato a seguito di uno studio condotto nel 1978 da Irving Selikoff. Asbestos and
desease, Academic Press, New York, 1978.
31