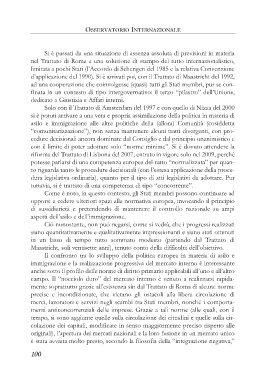Page 102 - Rassegna 2019-4
P. 102
OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
Si è passati da una situazione di assenza assoluta di previsioni in materia
nel Trattato di Roma a una soluzione di stampo del tutto internazionalistico,
limitata a pochi Stati (l’Accordo di Schengen del 1985 e la relativa Convenzione
d’applicazione del 1990). Si è arrivati poi, con il Trattato di Maastricht del 1992,
ad una cooperazione che coinvolgesse (quasi) tutti gli Stati membri, pur se con-
finata in un contesto di tipo intergovernativo: il terzo “pilastro” dell’Unione,
dedicato a Giustizia e Affari interni.
Solo con il Trattato di Amsterdam del 1997 e con quello di Nizza del 2000
si è potuti arrivare a una vera e propria assimilazione della politica in materia di
asilo e immigrazione alle altre politiche della (allora) Comunità (cosiddetta
“comunitarizzazione”), non senza mantenere alcuni tratti divergenti, con pro-
cedure decisionali ancora dominate dal Consiglio e dal principio unanimistico e
con il limite di poter adottare solo “norme minime”. Si è dovuto attendere la
riforma del Trattato di Lisbona del 2007, entrato in vigore solo nel 2009, perché
potesse parlarsi di una competenza europea del tutto “normalizzata” per quan-
to riguarda tanto le procedure decisionali (con l’estesa applicazione della proce-
dura legislativa ordinaria), quanto per il tipo di atti legislativi da adottare. Pur
tuttavia, si è trattato di una competenza di tipo “concorrente”.
Come è noto, in questo contesto, gli Stati membri possono continuare ad
opporsi a cedere ulteriori spazi alla normativa europea, invocando il principio
di sussidiarietà e pretendendo di mantenere il controllo nazionale su ampi
aspetti dell’asilo e dell’immigrazione.
Ciò nonostante, non può negarsi, come si vedrà, che i progressi realizzati
siano quantitativamente e qualitativamente impressionanti e siano stati ottenuti
in un lasso di tempo tutto sommato modesto (partendo dal Trattato di
Maastricht, soli ventisette anni), tenuto conto della difficoltà dell’obiettivo.
Il confronto tra lo sviluppo della politica europea in materia di asilo e
immigrazione e la realizzazione progressiva del mercato interno è interessante
anche sotto il profilo delle norme di diritto primario applicabili all’uno e all’altro
campo. Il “nocciolo duro” del mercato interno è venuto a realizzarsi rapida-
mente soprattutto grazie all’esistenza sin dal Trattato di Roma di alcune norme
precise e incondizionate, che vietano gli ostacoli alla libera circolazione di
merci, lavoratori e servizi negli scambi tra Stati membri, nonché i comporta-
menti anticoncorrenziali delle imprese. Grazie a tali norme (alle quali, con il
tempo, si sono aggiunte quelle sulla circolazione dei cittadini e quelle sulla cir-
colazione dei capitali, modificate in senso maggiormente preciso rispetto alle
originali), l’apertura dei mercati nazionali e la loro fusione in un mercato unico
è stata avviata molto presto, secondo la filosofia della “integrazione negativa,”
100